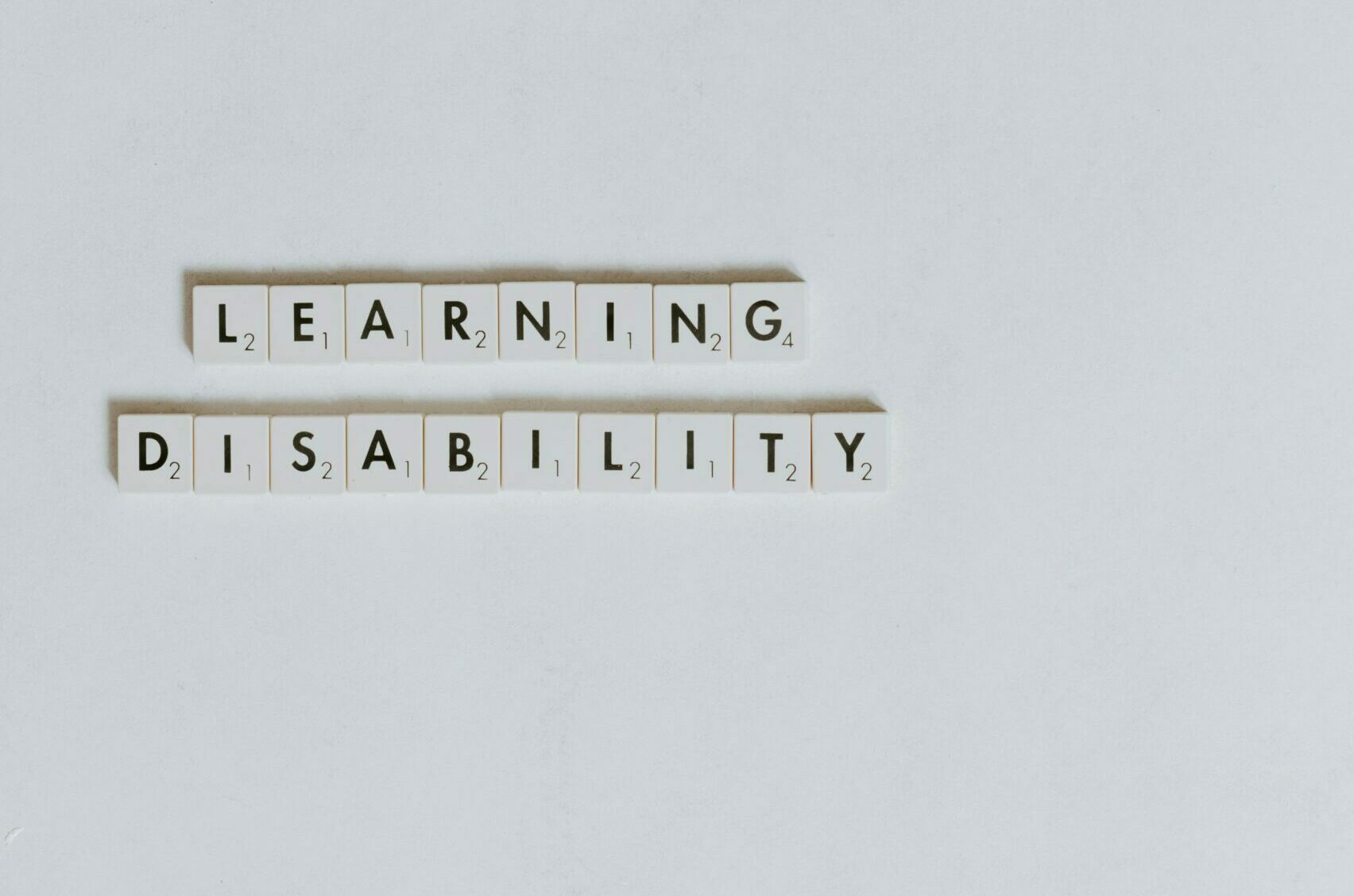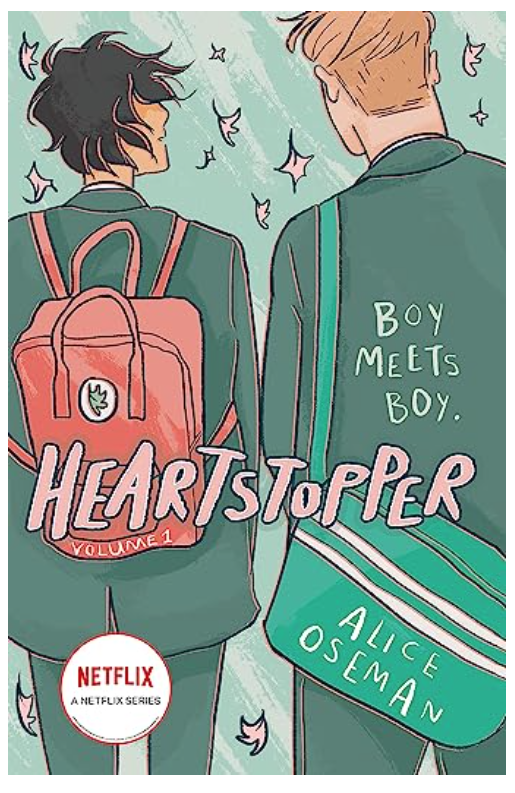Quella della legge sulle unioni civili è stata una vera e propria Odissea, costellata di pericoli, ostacoli e tanto coraggio. Protagonista di questa avventura legislativa è stata una parlamentare: Monica Cirinnà. Qui i suoi ricordi di quel periodo.
A sette anni dalla sua approvazione – l’11 maggio 2016 – la legge sulle unioni civili è rimasta, purtroppo, l’unico rilevante intervento del Parlamento italiano in materia di diritti civili delle persone lgbtqia+. Una legge che, dopo decenni di lotte, ha colmato un vuoto normativo intollerabile, restituendo dignità a migliaia di persone e coppie che chiedevano soltanto di essere riconosciute e tutelate. Un passo molto importante, quindi, che io stessa ho sempre interpretato e descritto come una tappa intermedia nel cammino verso la piena eguaglianza; una legge importante, ma incompleta sul fronte della tutela delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso. Il mio buco nel cuore, i cui effetti stiamo purtroppo vedendo ancora in queste settimane. A che punto era l’Italia nel 2013, quando iniziò quella indimenticabile avventura parlamentare?
Nel 2010 la Corte costituzionale aveva sancito, per la prima volta, che tra le formazioni sociali protette dall’articolo 2 della Costituzione rientra “l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”. Diritto fondamentale, dunque, la cui disciplina spettava però al legislatore, cioè alla politica. Quella politica che ancora adesso troppe volte, davanti a moniti e pronunce delle più alte Corti, preferisce decidere di non decidere. Allora non fu così. Ci mettemmo in cammino e a me venne affidato il difficile compito di relatrice. La scelta fu quella, prudenziale per l’epoca, dell’unione civile: istituto diverso dal matrimonio, ma su questo modellato al millimetro. Una scelta non dissimile da quella di paesi europei a noi vicini, come la Germania, la Svizzera o l’Austria: ma diversa da quella, più radicale e da me preferita, del matrimonio egualitario. Se guardo indietro e considero il tempo trascorso, vedo però che nei paesi in cui vennero fatte scelte analoghe – come, appunto, Svizzera, Germania e Austria – queste hanno rappresentato solo un primo passo verso il matrimonio egualitario: una speranza che coltivavo anche per l’Italia e per la quale continuo a lottare.
L’iter parlamentare non fu semplice e, nel luglio del 2015, venne accelerato da una importante sentenza con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo condannò l’Italia per il mancato riconoscimento della vita familiare delle coppie omosessuali. In quei mesi ebbi la fortuna di incontrare, conoscere e confrontarmi con le associazioni e la comunità lgbtqia+ di tutta Italia. Ricordo incontri, anche tesi, ma sempre costruttivi e propositivi. Nacque una vera e propria rete di contatti e supporto che mi ha accompagnata per tutto l’iter della legge e che ho continuato a tessere anche dopo la sua approvazione, consapevole che è ascoltando la voce di chi le istanze le vive sulla propria pelle, di chi da decenni si batte in prima persona, senza tutele, spesso rischiando, che la politica può davvero migliorare la vita delle persone. Ovvero, fare il proprio lavoro. E che solo quando c’è una forte spinta dal basso, dalla società, i cambiamenti veri possono avvenire, nonostante i giochetti di palazzo. Proprio in quelle settimane entrarono nel vivo i lavori della Commissione Giustizia del Senato. Ricordo le sedute fiume, anche notturne, in cui mi trovavo a fronteggiare discussioni surreali su emendamenti formulati per denigrare, insultare e banalizzare in termini comici i contenuti del testo. Drammaticamente comici, però, perché un ostruzionismo di quel genere, che colpisce la vita delle persone e la legittima aspettativa di felicità di tante coppie e di tante famiglie, fa male ed è l’antitesi della buona politica. Andammo avanti con uno schema parlamentare che pareva solido: il PD, che sembrava non mostrare crepe, il Movimento 5 stelle – anni prima di qualunque prospettiva di collaborazione politica – e le forze alla nostra sinistra. Da loro mi sentii, per molti mesi, sostenuta con sincerità e mi fu così possibile lavorare – anche assieme a Sergio Lo Giudice e Beppe Lumia, miei colleghi in Commissione e amici indimenticabili – a mediazioni molto faticose. Ci dedicammo a ben quattro stesure del testo, per rispondere a obiezioni spesso capziose, ma difendendo strenuamente quelli che per me erano punti irrinunciabili: un istituto diverso dalla mera disciplina delle convivenze, con una celebrazione e una pubblica assunzione di responsabilità, stessi diritti patrimoniali e successori rispetto al matrimonio, compresa la reversibilità della pensione, adozione del figlio del partner (la famosa stepchild adoption, sulla quale tornerò). Il testo, nella sua ultima stesura, venne letteralmente sommerso da emendamenti: pretestuosi, ideologici o semplicemente ridicoli. Continuammo fino all’autunno del 2015, e poi decidemmo di andare in Aula senza relatore: in mare aperto, ma confidavo che la coalizione che in Commissione aveva resistito agli assalti della destra oscurantista rimanesse salda anche in Aula.
Fu in quel momento, a fine gennaio del 2016, che quella rete di associazioni, la comunità lgbtqia+, tantissime altre realtà, semplici cittadine e cittadini invasero letteralmente le piazze del Paese. “Svegliati Italia” riempì più di 100 piazze di tutta Italia, molte anche all’estero: penso, ad esempio, alla Germania o all’Irlanda, dove italiane e italiani residenti all’estero organizzarono mobilitazioni locali. Un’istantanea meravigliosa di una società che non era disposta a cedere di un millimetro né a rimandare ulteriormente quel necessario passo verso l’uguaglianza. In piazza non c’erano solo le persone lgbtqia+: c’erano tutte e tutti. C’era il Paese.
Scoprii presto, purtroppo, che l’alleanza che c’era stata in Commissione, non si sarebbe replicata in Aula. Non dimenticherò mai quel mese di febbraio del 2016: il Senato aperto ai rappresentanti delle associazioni, che dalla tribuna assistevano ai lavori dell’Aula. La commozione in tanti interventi appassionati a sostegno della legge; l’indignazione di fronte a illazioni vergognose e all’uso di linguaggio apertamente omofobo; il problema di gestire centinaia di emendamenti e, infine, il tentativo di approvare un emendamento premissivo (il famoso “canguro”) che avrebbe determinato la decadenza di moltissimi emendamenti facilitando l’approvazione del testo. Un tentativo purtroppo fallito – nella drammatica seduta del 16 febbraio 2016 – per l’inaspettato voltafaccia del Movimento 5 Stelle, che si rifiutò di votarlo. A quel punto, fu necessario cambiare schema e portare la legge nel perimetro della maggioranza di governo: al sicuro? Per modo di dire: la maggioranza dell’epoca comprendeva infatti forze di centrodestra, contrarie alla legge. Ricominciò la girandola delle discussioni e delle mediazioni e alla fine fu chiaro che, per salvare almeno la possibilità di dare riconoscimento alle coppie, sarebbe stato necessario rinunciare, con dolore, ad alcune parti importanti dalla legge. Furono giorni di grande sofferenza: i giorni delle inaccettabili pressioni per togliere il riferimento alla vita familiare o in alternativa all’obbligo di fedeltà e i giorni, soprattutto, dello stralcio della stepchild adoption e del voto di fiducia. Giorni in cui, nella piazza sotto Palazzo Madama, le associazioni si diedero appuntamento arrivando da molte città d’Italia. Una protesta forte, ma pacifica, che urlava a gran voce che no, quella legge non andava toccata ancora. Che era già un compromesso rispetto al traguardo del matrimonio e che oltre a quello non si doveva andare. Ricordo l’occupazione di Corso Rinascimento da parte di attiviste e attivisti, a volte oggetto di provocazioni da parte dei miei colleghi della destra oscurantista. Fu Sergio Lo Giudice, che dal mondo dell’attivismo arrivava, a scendere in strada per riferire quello che stava succedendo in aula.
La legge fu approvata e il successivo passaggio alla Camera fu veloce e molto meno conflittuale. Il 20 maggio arrivò la firma del Presidente della Repubblica e il 5 giugno la legge entrò in vigore.
Non dimenticherò la felicità negli occhi di tante coppie, soprattutto anziane, la commozione di poter finalmente concludere un tempo infinito di attesa e dare sicurezza alla propria vita insieme. Ma non dimenticherò neanche, però, le lacrime e il senso di umiliazione delle famiglie arcobaleno, che sento sulla mia pelle, da allora, ogni giorno. Molto sarebbe cambiato, grazie soprattutto al lavoro dei giudici e di molti sindaci coraggiosi. Ma quella ferita, per loro e per me, rimane.
Sono passati sette anni in cui la legge sulle unioni civili si è rivelata, come speravamo, non solo lo strumento della felicità di migliaia di persone e coppie ma anche una fondamentale leva culturale che ha diffuso in tutto il paese il senso e la percezione di una cittadinanza eguale, della eguale bellezza dell’amore, della gioia “di pochi” o “degli altri” che, all’improvviso, diviene possibile condividere nei municipi, nelle piazze di questo nostro Paese. Questi anni trascorsi ci raccontano di un clima profondamente cambiato. Lo stiamo vedendo, ancora in questi giorni, a proposito di quel che sta accadendo alle famiglie arcobaleno: la morsa che il governo di destra estrema vorrebbe imporre sulle bambine e sui bambini con genitori dello stesso sesso, privandoli di riconoscimento ed elementari diritti di figlie e figli sta incontrando nel Paese una resistenza profonda, che è frutto anche di quella legge e del modo in cui ha “lavorato” nella coscienza pubblica, creando un sostanziale principio di uguaglianza di tutti gli amori. È un motivo di gioia collettiva sapere che con la celebrazione di ogni unione civile nasce una nuova famiglia, uguale a tutte le altre, grazie ad una legge che riconosce pari dignità, e pari diritti e doveri, a tutte le coppie che si amano. Ho rafforzato la mia convinzione che la politica può essere positiva e costruttiva quando si occupa delle vite delle persone, riconoscendo loro quei diritti prima taciuti o negati, fonte sempre di tanti, troppi, dolori e discriminazioni.
Per questo, ora che sono fuori dal Parlamento, per una precisa scelta politica del PD, penso con sollievo alla resistenza dei Sindaci, penso ai tanti sondaggi che dimostrano che il livello di comprensione delle istanze di riconoscimento delle famiglie omogenitoriali è ormai elevatissimo. Vedo un Paese che deve compiere ancora un lungo cammino ma che, grazie anche a quella legge, e all’incessante e prezioso lavoro della comunità lgbtqia+, può camminare su gambe solide e con maggiori certezze.