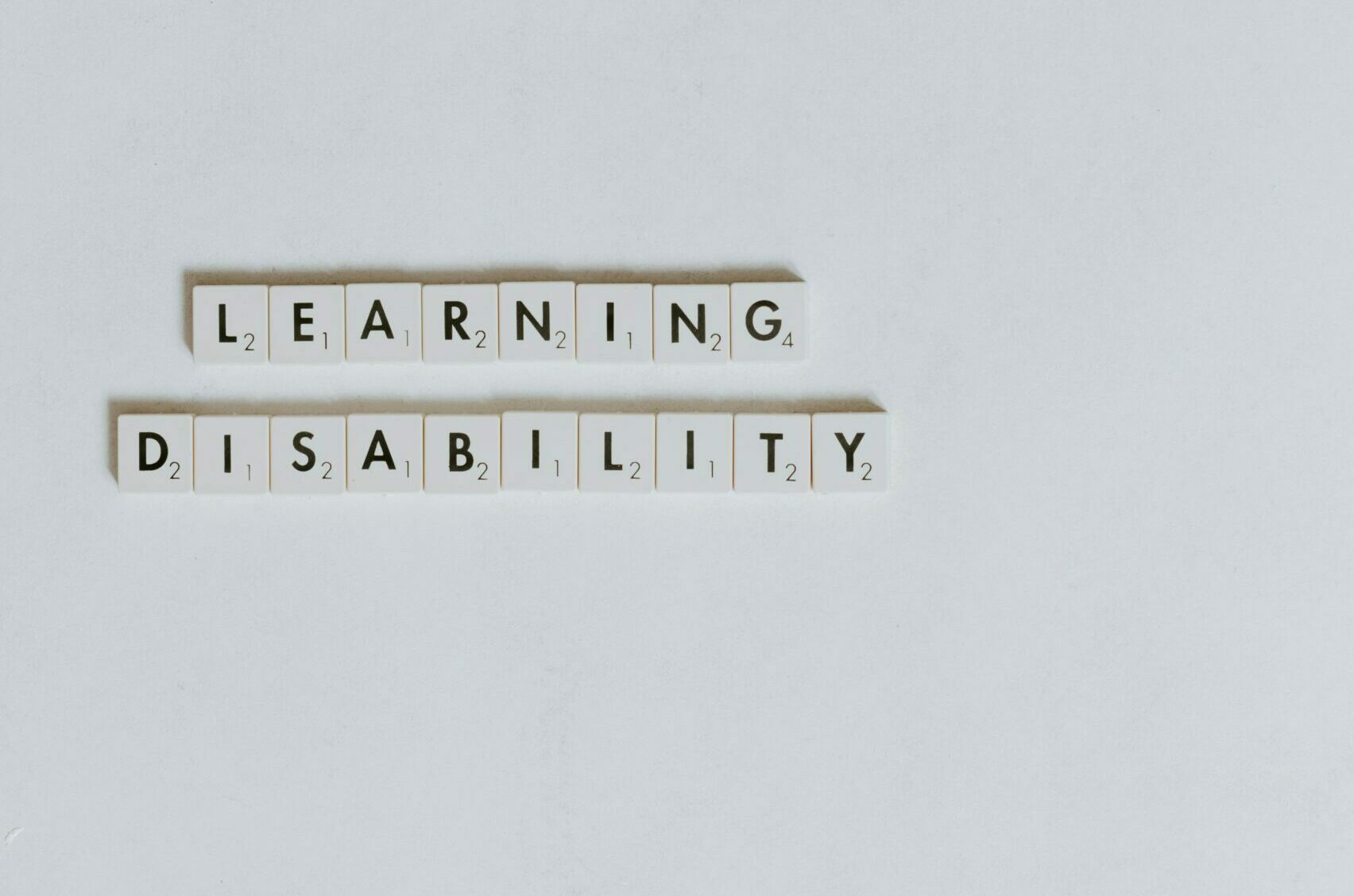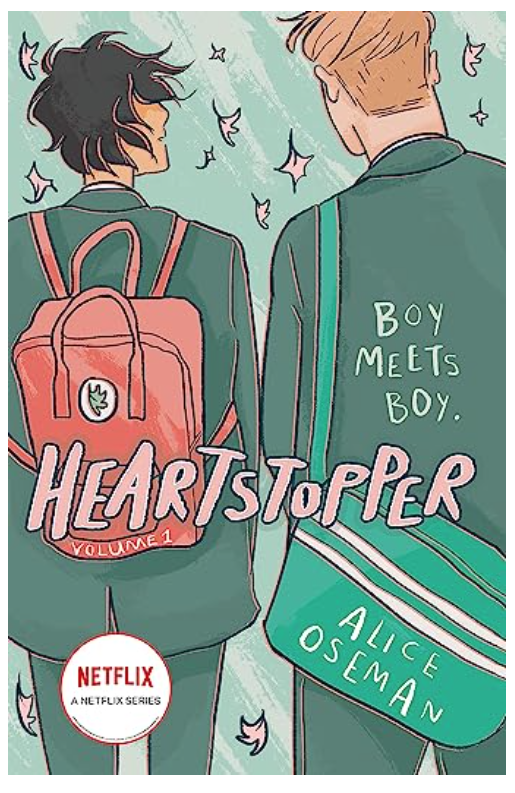La comunità queer sembra più visibile di sempre, costantemente oggetto di conversazioni politiche che di positivo hanno ben poco. Eppure, rimaniamo ai margini di una società che non ci considera degni di rispetto. Per non parlare delle persone non bianche. In una società che riesce a convivere con il fatto che negli ultimi 10 anni più di 25mila persone black and brown sono morte o date disperse nel Mediterraneo, com’è possibile per le persone non bianche sul territorio sentirsi viste, sentite, trattate con rispetto?
“Quando sei abituato ad essere invisibile, con il tempo poi risulta difficile farti vedere e sentire quando la situazione lo richiede”.
E’ una frase che mi si imprime nel cervello e mi resta in testa per giorni.
Me la dice Clotilde Petrosino mentre discutiamo di come impostare una talk sul suo progetto “The queer talks” nei prossimi giorni. Si fatica a trovare persone disposte a mettersi davanti ad un microfono. Non è la prima volta che capita.
Quando non faccio le capriole per pagare l’affitto milanese, prendo parte a progetti editoriali, fotografici, corti, interviste e anche spot commerciali in cui sfoggiare un po’ di black queerness, perché mi fa bene e trovo ce ne sia un gran bisogno.
La rappresentazione e l’immaginario collettivo cambiano a mio parere con la presenza reale di persone diverse da quelle a cui ci hanno abituati per troppo tempo.
Chi sta dietro a certi progetti spesso lamenta la difficoltà di trovare soggetti disposti a farsi ritrarre, intervistare, vedere.
Tolta l’ovvia comprensione per chi semplicemente non si vuole esporre per privacy o carattere, è veritiero il fatto che nella città più rainbow dello stivale a volte pare di vedere sempre le stesse facce.
“Quando sei abituato ad essere invisibile, con il tempo poi risulta difficile farti vedere e sentire quando la situazione lo richiede”
Risuona come un monito, una funesta lettura del futuro.
Di recente la comunità queer sembra più visibile di sempre, costantemente oggetto di conversazioni politiche che di positivo hanno ben poco. Ironico. Eppure, quando non utilizzati come sacco da boxe della destra italiana, rimaniamo ai margini di una società che non ci considera degni di rispetto.

Nel suo l’undicesimo report annuale sui diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali in Europa e in Asia centrale, ILGA Europe posiziona l’Italia 33esima su 49 paesi.
Nella ricerca vengono osservati indicatori quali uguaglianza, questioni familiari e incitamento all’odio, riconoscimento legale del genere, libertà di espressione e diritti di asilo. In una scala di valori compresa tra 0% (violazioni gravi dei diritti umani, discrimanzione) e il 100%( piena uguaglianza, rispetto dei diritti), l’Italia racimola il 24,76%.
Vivo in questo paese da trent’anni. Sono stata la macchia di colore, il token, l’unica nera nella stanza nei più svariati contesti quotidiani. La cittadinanza italiana sulla mia carta d’identità racconta la storia di una famiglia, tra le tante, riuscita a strappare alle grinfie della burocrazia italiana quel piccolo spazio necessario a tirare veramente il fiato e ad essere presenza politica al pari di altri.
Una sicurezza cartacea che non ripara però dall’essere usati come capro espiatorio per le politche interne di un paese che, senza troppa fantasia, alimenta una guerra tra poveri ed emarginati continua, dove il cassaintegrato punta il dito all’immigrato e non all’azienda, dove la babygang di quartiere fa più paura della mafia di stato.
Recenti dati Istat confermano che “In Italia, al 1° gennaio 2020, i ragazzi minorenni di seconda generazione in senso stretto (nati in Italia da genitori stranieri) sono oltre 1 milione; il 22,7% dei quali (oltre 228 mila) ha acquisito la cittadinanza italiana”. Per gli altri 700mila e passa ragazzi senza cittadinanza, la visibilità in quanto figli dello stato è ancora lontana.
La questione cittadinanza è l’ennesima riprova che l’Italia ha un problema nel riconoscersi in forme e colori che non siano, diciamolo assieme, quelle del: maschio, bianco, etero, cis. Il razzismo sistemico di cui è pervasa la società intera prende sostanza nel continuo ostacolare forme di apertura, integrazione e uguaglianza per gli altri.
Ho preso ad esempio la cittadinanza che è in discussione on/off da vent’anni, ma questioni ugualmente urgenti sono quelle della disposizione di vite umane all’interno dei Centri di Permanenza per Rimpatri, così come quelle dei flussi migratori, dei respingimenti, delle morti nel Mediterraneo. Corpi che paiono lontani e irreali e che invece si accumulano come foglie d’autunno sul giardino delle coste del sud Italia.
Non riuscire ad empatizzare e a problematizzare questi fenomeni è una colpa governativa, mediatica, culturale e storica. Un paese che ancora fatica a fare i conti con le sue responsabilità in ambito coloniale è difficile che riesca ad affrontare un futuro all’insegna della diversità. L’opinione pubblica poi viene ingozzata di notizie che profumano di pornografia del dolore da una parte o sostituzione etnica dall’altra e prende posizione scannandosi in 130 caratteri online, per poi chiudere le app e andare avanti.
In una società che riesce a convivere con il fatto che negli ultimi 10 anni più di 25mila persone black and brown sono morte o date disperse nel Mediterraneo, com’è possibile per le persone non bianche sul territorio sentirsi viste, sentite, trattate con rispetto?
Com’è possibile assistere a mobilitazioni e indignazioni per le morti degli afro americani sotto il giogo della polizia statunitense e non percepire la stessa rabbia per Alika, ucciso in strada in pieno giorno davanti a testimoni armati di cellulare? O per Emmanuel, ucciso in questo periodo 7 anni fa, reo di aver difeso la moglie da insulti razzisti da parte di un ultrà di estrema destra?
I nomi sono tanti e le situazioni insulse. L’indignazione generale, mai sufficiente.
La cecità di chi ci sta attorno risulta fin troppo ben distribuita, anche con le migliori delle intenzioni.
In una dimensione più intima, ma non meno politica, la mia invisibilità è quella di una persona nera&queer, che ama e progetta un futuro in un paese ove non è concepibile il suo benessere, dove la sicurezza è un punto di domanda e dove chiaramente non è riconosciuta una reale parità di diritti. Solo una banalissima necessità di doveri e di obblighi a livello fiscale per tutti. Tradotto: paga le tasse ma non ti sposare e non figliare (e se hai già figliato non pretendere di essere genitore, non è scontato). Le persone nere che si identificano come queer affrontano il doppio peso del razzismo e dell’omofobia, amplificando la loro invisibilità all’interno della società occidentale.
A un livello ancora più ristretto è la mia stessa comunità a non vedermi del tutto perchè l’intersezionalità impone un’ennesima distanza tra ciò che è queer e ciò che è nero&queer.
Nonostante la comunità LGBTQIA+ si sforzi di essere inclusiva, il razzismo può persistere all’interno dei suoi spazi. Questo sfocia in marginalizzazione, microaggressioni condite di “Amo, io mi sento nera dentro”, appropriazione culturale a condire e feticizzazioni becere di cui sono piene le chat Grindr, dove gli uomini gay non bianchi vengono automaticamente considerati stalloni da monta e non persone con gusti sessuali da scoprire e chiedere perché, appunto, non considerate persone.

Al mio nera&queer altrз potrebbero aggiungere &trans &non-binary e si sentirebbero ancora più solз a tratti, in una stratificazione continua di identità che però ha bisogno di trovarsi e comprendersi per affrontare istanze comuni. Fondamentale il riconoscimento del proprio privilegio anche quando si è parte di una minoranza. All’interno della comunità a volte è difficile esprimere chiaramente questo concetto e riuscire a parlarne senza provocare un’offesa nell’interlocutore. Eppure il concetto è brutalmente semplice: c’è sempre qualcuno che se la passa peggio di te. Renderci conto del nostro privilegio ci aiuta a capire la differenza tra le nostre esperienze e quelle altrui, a empatizzare con il prossimo e ad acquisire responsabilità sociale.
Lecito quindi ripensare alla frase dell’incipit con un minimo di timore.
A furia di non essere visti, si rischia di abituarsi a stare fuori dalla periferica altrui, ai margini, dove pare più sicuro rimanere o in ambienti safe, perché è umano ricercare spazi sicuri in cui sentirsi capiti e accettati.
I social in questo hanno aiutato; ci hanno sicuramente fatto il regalo di vederci e riconoscerci in persone e situazioni lontane chilometri da noi. Ci hanno reso possibile organizzarci e sincronizzarci su nuove frequenze e prese di coscienza. Ci hanno donato un senso di collettività e comprensione che prima era più difficile da ottenere in poco tempo.
I pericoli che i social nascondono sono diversi, primo su tutti lo sdoganamento dell’odio anonimo, a mio parere. Ma quello che mi preoccupa di più è ciò che accade quando si stacca la spina, il niente a schermo spento. Io per prima a volte chiudo ed elimino app e mi ritiro dalla pubblica piazza. Un po’ per salvaguardare il benessere mentale dal bombardamento di informazioni, discussioni, trigger warning e un po’ perché ho bisogno delle persone più dei like.
Trovo che per non dimenticarci di noi, per non rimanere invisibili e comodi nell’invisibilità, sia necessaria la presenza di una comunità reale, persone vere che ci guardano negli occhi e ci ricordano che sono lì anche loro per lo stesso motivo. La frustrazione, la paura e, soprattutto, la rabbia sono strumenti che hanno dato vita alle più grandi rivoluzioni. Stonewall è partita con la resistenza a pubblici ufficiali e attraverso il lancio di bottiglie.
Unire la nostra ira e indignazione a quella degli altri amplifica le nostre voci.
L’abbraccio collettivo di chi lotta assieme a noi lenisce le nostre ferite.
Forse per rimanere visibili e visti, dobbiamo non dimenticarci di cercarci negli occhi degli altri.