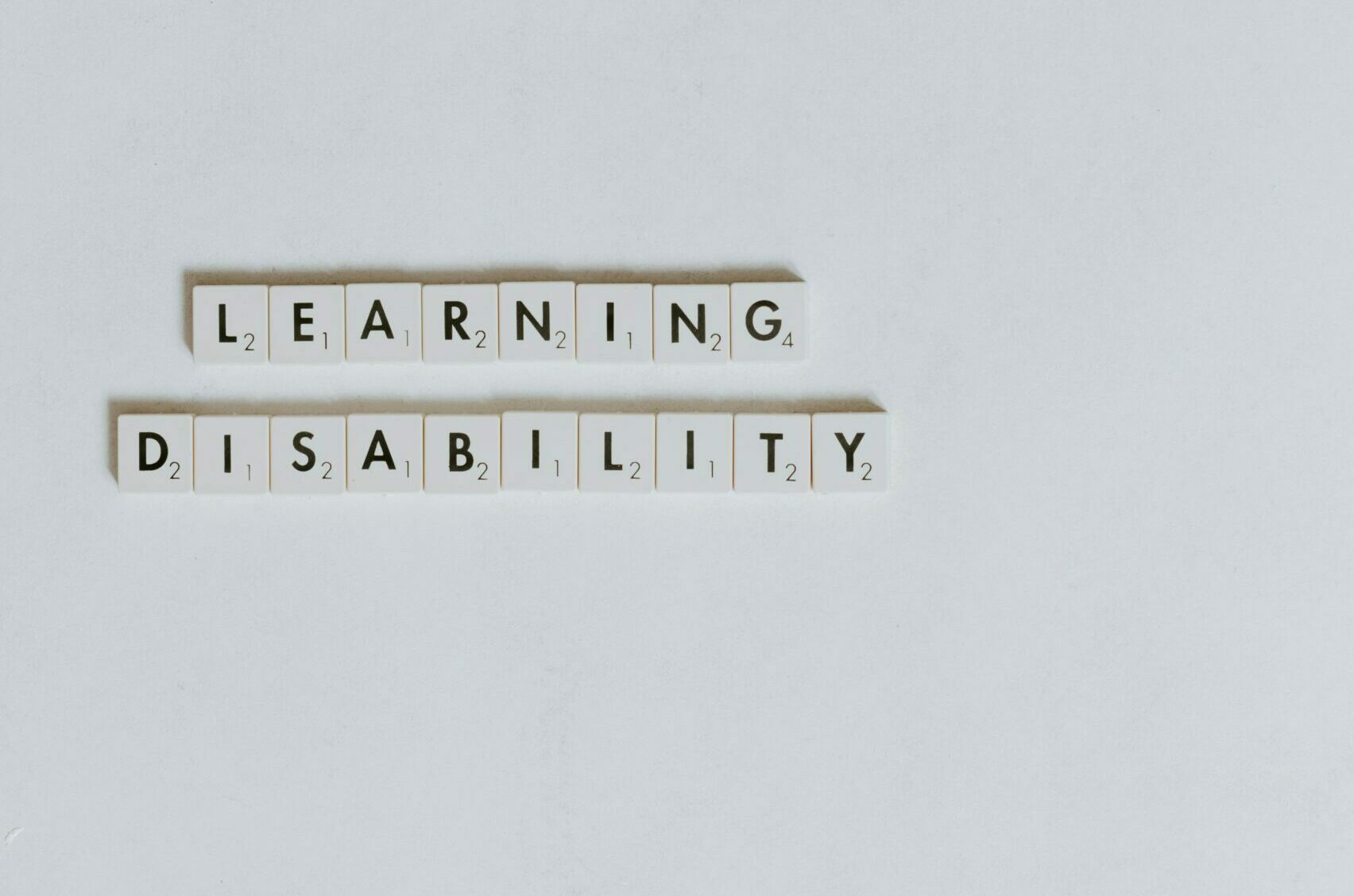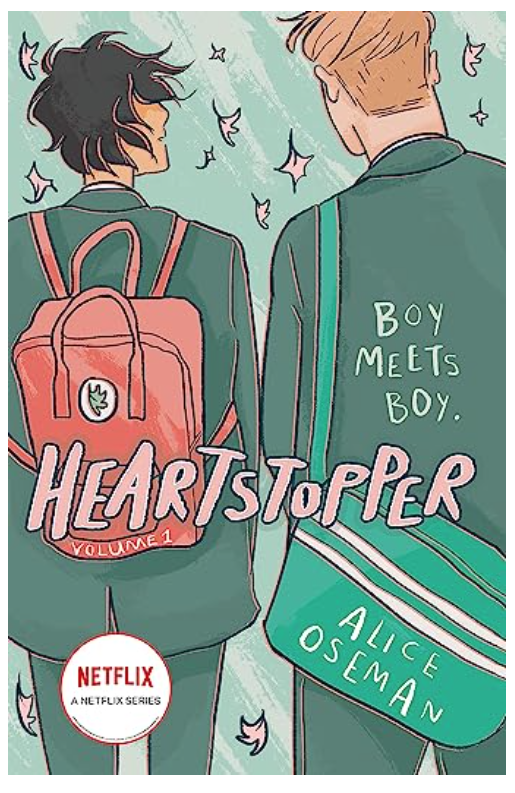Premessa: il testo di seguito eccede in inglesismi e pecca di obiettività. Mi perdonerete, Madonna è la mia living icon più importante e non ho alcuna intenzione di essere obiettivo nei suoi confronti. Quello che leggerete di seguito, se vi va, è il mio punto di vista -nonché atto d’amore- sullo show del Celebration Tour che Sua Maestà sta portando in giro per il mondo. E ne parlo a poche settimane dalla data di Colonia a cui ho assistito dopo un viaggio della speranza durato quasi 3 giorni. E ne è valsa la pena.
Quando Murgia ha sdoganato il tema delle famiglie queer, io avevo già il biglietto in tasca, ho ragionato sul fatto che personalmente vivo all’interno di più famiglie queer e che il concetto si trasla facilmente anche alle comunità di relazioni. E non ho dubbi, devo dire che quella di Madonna è la più grande per cui sento appartenenza e fede. Nelle famiglie queer ci si ama e ci si riconosce, ben oltre i legami di sangue. C’è qualcosa di più ancestrale che ci unisce, qualcosa di determinante e fondante che ci disegna come persone.
Ebbene, il Celebration Tour di Madonna, dal momento in cui si spengono le luci fino all’ultimo secondo dello show, è un immenso catalogo di tutto quello che amiamo e che ci definisce, declinato al passato, presente e futuro.
40 anni di carriera sono snocciolati in uno show che ha la potenza di un film, di quel biopic che stava per vedere la luce prima di dedicarsi al tour e che sicuramente l’ha vista ripensare a tutta la sua carriera. L’opening act è Nothing really matters, un pezzo sofisticato e potente che rappresenta ancora uno dei suoi più forti statement e allo stesso tempo la dedica perfetta ai suoi fans di sempre: “nothing really matters, love is all we need, everything I give you, all comes back to me”.
Poi c’è New York, gli anni ’80, per essere cool bastava un po’ di denim e tanti accessori, il Danceteria, il club dove tutto è iniziato, dove una giovane Madonna faceva carte false pur di entrare perché lì accadevano le cose. Ci sono le polaroid di Maripol, i braccialetti di caucciù e una combriccola di personaggi eccentrici, oggi diciamo queer ma non abbiamo inventato niente. È tutta lì la queer family di Madonna, vite sopra le righe (leggi fuori norma) che si ritrovano al sabato sera a ballare in disco, dove tutto è possibile, dove ci si ama e ci si odia in libertà, dove la stravaganza si fa arte e il genere conta zero. Ci sono Basquiat, la mirror ball, il punk, le giacche con le stampe di Keith Haring.
The party is over, nel peggiore dei modi. Dopo la festa, la tragedia. Arriva il dramma dell’aids, la peste dei gay, un ballerino cade a terra, senza respiro. Madonna lo copre con la sua giacca. È Martin Burgoyne, cameriere al Danceteria, amico e coinquilino, morto per aids nel 1986, 23 anni. Ma è anche Keith Haring, morto per aids nel 1990, 31 anni. Ed è anche Christopher Flynn, mentore e primo maestro di danza quando Madonna viveva ancora in Michigan, morto per aids nel 1990, 59 anni. Ed è anche Gabriel Trupin, ballerino durante il Blond Ambition Tour, morto per aids nel 1995, 26 anni. E così va Live to tell, Madonna sospesa in alto mentre negli schermi scorrono le foto dei suoi amici, della sua chosen family e di tantə che hanno perso la vita in quegli anni terribili. Live to tell, vivere per raccontare. Nell’epoca dello storytelling il messaggio arriva forte e potente, anche se noi hard fans ricordiamo lo schiaffo in faccia che la divina diede all’America puritana e al cattolicesimo bigotto parlando di libertà e consapevolezza sessuale, mostrando il preservativo sul palco al grido di “don’t be silly, put a condom on your willy”. Era il 1990. Tra una lacrima e l’altra mi sento sopravvissuto anche io, porterò con me la responsabilità della memoria.

D’altronde, la memoria è il motore dello spettacolo. Madonna è testimone di fatti salienti portatori di grandi cambiamenti culturali. Lei c’era e ce lo racconta; noi siamo lì e sfogliamo con lei un grande album di fotografie. C’è la sua educazione artistica e culturale: David Bowie, Sinead O’Connor, Tamara de Lempicka, James Baldwin, Frida Kahlo, Nina Simone, Che Guevara, Martin Luther King, Malcolm x, Martha Graham. C’è il lungo cammino dei diritti, le prime marce del pride, Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson. C’è Prince, impersonato alla fine di Like a prayer dal figlio David Banda come ringraziamento per le chitarre di sottofondo della canzone, non accreditate ma volute da Madonna per dare al pezzo quel tocco di solennità che ne hanno fatto un classico. C’è Michael Jackson, in un duetto commovente con una giovane Madonna all’inizio della sua carriera sulle note di Billie Jean e Like a virgin. C’è una (lunga) carrellata di foto dei suoi (e delle sue) amanti. Ci sono le parole di stima di Beyoncé e Ariana Grande ma anche le parole di scherno di Cher e di tanta stampa che non ha mai creduto in lei. She’s still around, bitches!
E per venire a noi, ci sono le famiglie, quella di sangue e quella di elezione, mentre canta Mother and Father con il figlio David e le foto dei loro rispettivi genitori, un modo per chiudere il cerchio dopo tanti anni di rapporti apparentemente irrisolti. Perché, in fondo, quello che Madonna ci ha sempre insegnato è che non è nei legami di sangue che si trova la pace.
E nemmeno nella religione, evidentemente. The beast within è una denuncia a ogni forma di guerra in nome della religione. Lei legge l’Apocalisse e il palco è avvolto dalle fiamme dell’inferno. Letteralmente. In Like a Prayer i ballerini diventano martiri, le croci si accendono e Madonna, oggi come 35 anni fa, vorrebbe fare i conti con una fede che dovrebbe essere amore e accoglienza e invece è giudizio ed esclusione. La redenzione non arriverà dall’alto ma da noi stessi e dalle nostre azioni.
C’è la passione, quella spirituale, della colpa e del dolore e quella fisica, che conduce al piacere. C’è Erotica, il sesso in un ring, “Once you put your hand in the flame, it can never be the same. There’s a certain satisfaction in a little bit of pain”.
E poi Vogue. Che nasce come b-side e diventa leggenda. Bob the Drag Queen è un pazzesco MC in questa ballroom super glam, con tanto di categoria sex-siren e guest judge a sorpresa. Sì, perché oggi impazziamo per i codici della ball culture, ma quando usciva Vogue Madonna non ha capitalizzato un trend, come spesso viene accusata, semplicemente perché non era tale. Madonna era lì, in quelle comunità che nessuno, gay per primi, voleva frequentare. Perché, se c’è una cosa che ha sempre saputo, è che la miccia dell’arte si accende ai margini, non nel privilegio. Madonna ha sempre giocato con i generi, con i ruoli, con il sesso, con le provenienze e le discendenze. Sul palco non ci sono differenze. Non ci facciamo caso, ma in questo tour non ci sono costumi da uomo su uomo o da donna su donna. Al contrario, l’estetica cancella il genere anche quando sono tuttə a torso nudo e, davvero, non ci pare così strano il corpo femminile nudo. Free the nipple. Ma che bella è questa grande queer crew (Daniele Sibilli ti amo!), un cast di 24 elementi tra ballerini, figlie e figlio (e nessuna band, ancora una volta Her Madgesty riscrive le regole) intorno alla boss.
Ci sarebbero tante altre cose da raccontare, i look iconici, le mosse, il letto di velluto rosso del Blond Ambition Tour dove mima (again) una masturbazione, Don’t cry for me Argentina, quando indossa una progress pride flag. E il finale mash-up tra Celebration, Music e Bitch I’m Madonna (se non l’avessi capito). La crew indossa i suoi outfit storici e lei ancora una volta un velo nuziale. Madonna celebra se stessa e tutti noi fans, che a quei look associamo periodi delle nostre vite, pride e innamoramenti in disco (e chi più ne ha…).

L’iconica Madonna che si reinventa di continuo, che guarda al futuro mentre il passato si cristallizza e diventa mito. Perché Madonna plasma il tempo, lo piega a suo favore. E noi fan o siamo su quel treno o non c’è perdono. Madonna non ha mai voluto essere rassicurante e forse nemmeno provocatoria. Il suo mestiere è sparigliare le carte. Distruggere per permetterci di ricostruire. Rompere la norma, sradicare il pregiudizio, inseguire il successo, assumersi il rischio senza chiedere il permesso. E tanti di noi, vedo, hanno ceduto: “non la riconosco più, è grottesca, si muove a malapena”. No baby, quello invecchiato e pure imborghesito sei tu.
Madonna è lì, sempre diversa e sempre uguale. Con lei tanti pezzettini di noi, della nostra identità fuori norma, della libertà di essere noi stessə senza dover chiedere il permesso, della sorellanza e della memoria.
Uno dei miei momenti preferiti dello show, sempre a proposito di queer family, e quando racconta della malattia e del risveglio, il pensiero alle figlie e ai figli e a quanta forza le hanno dato, chitarra in mano, scenografia quasi zero, canta I will survive. Perché lei sopravvive e noi celebriamo. E perché, essendo la suddetta canzone uno dei maggiori inni di resistenza LGBTQIA+ di tutti i tempi, lei canta anche per noi, che siamo tuttə suə figliə e lei è la nostra Queen Mother Madonna.