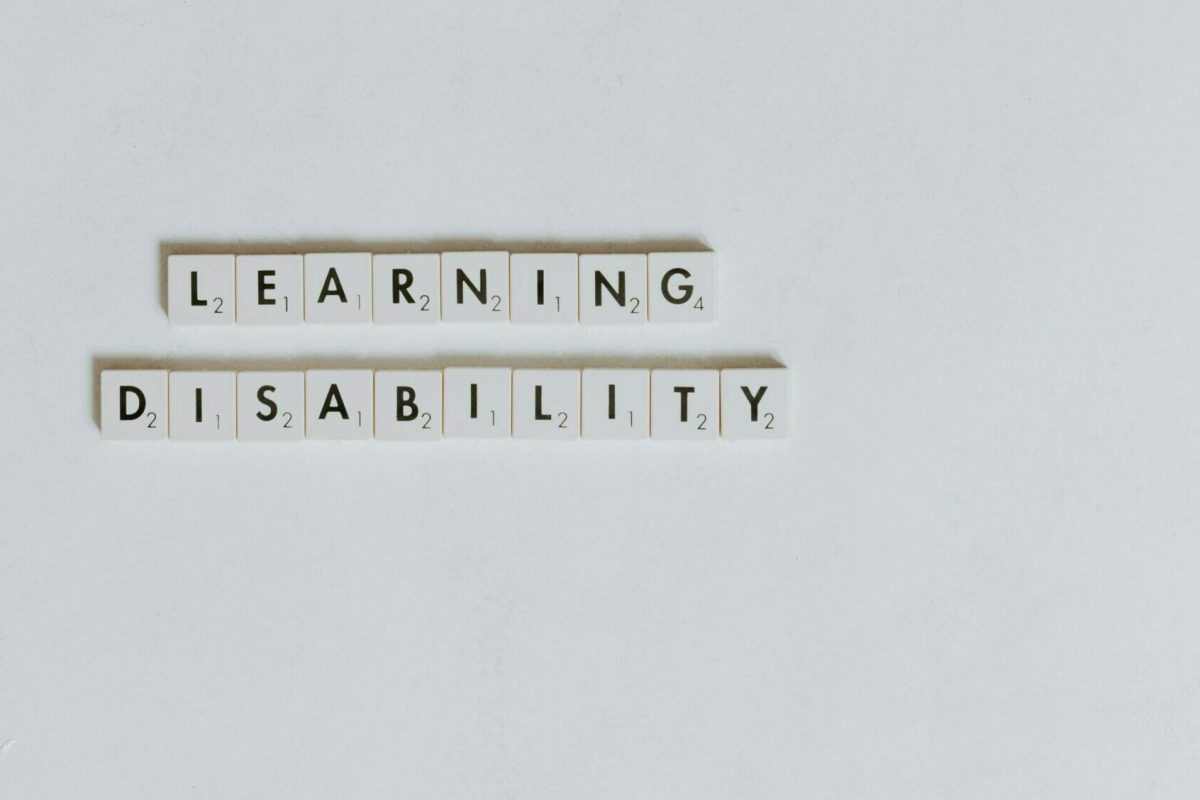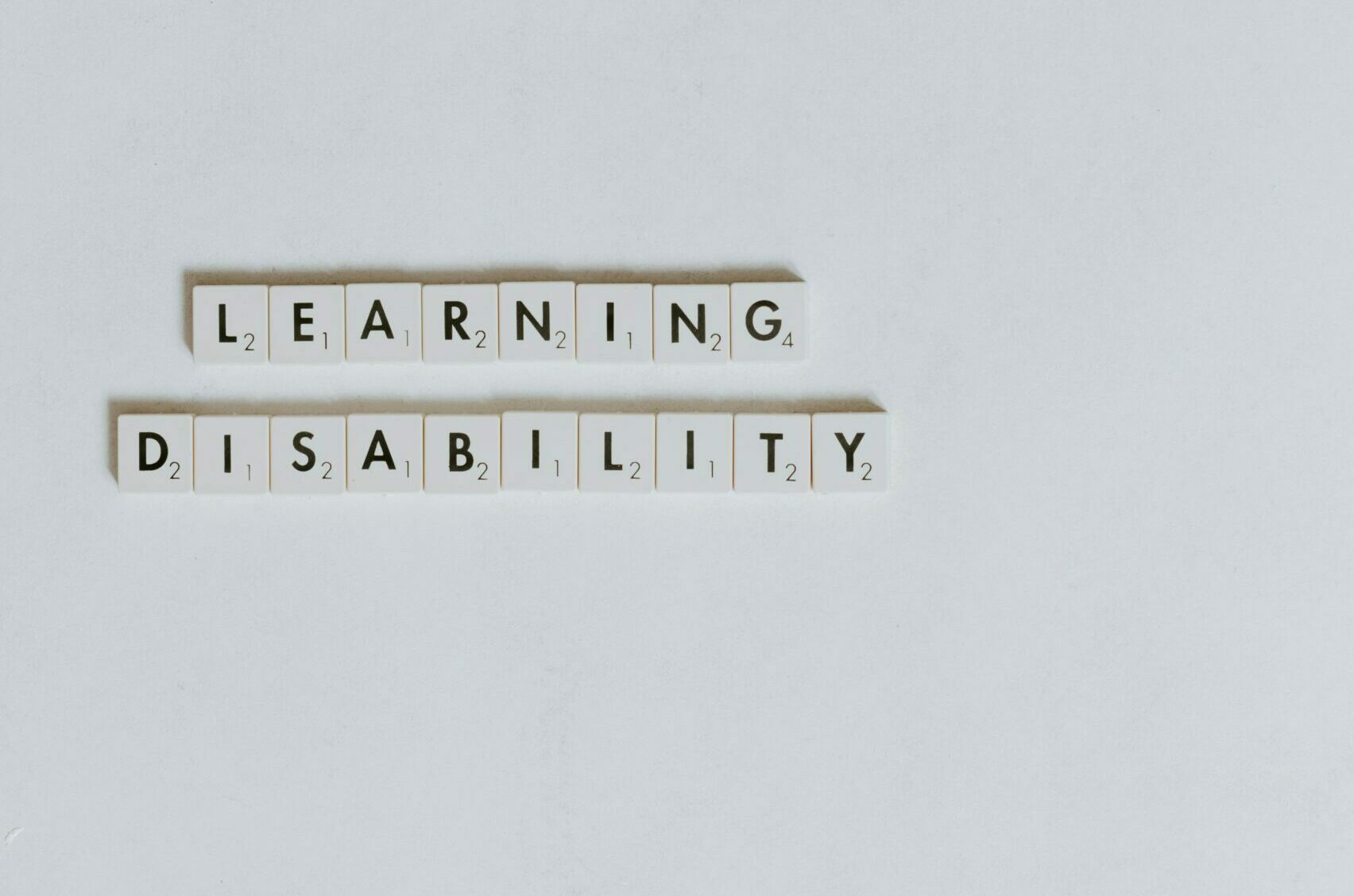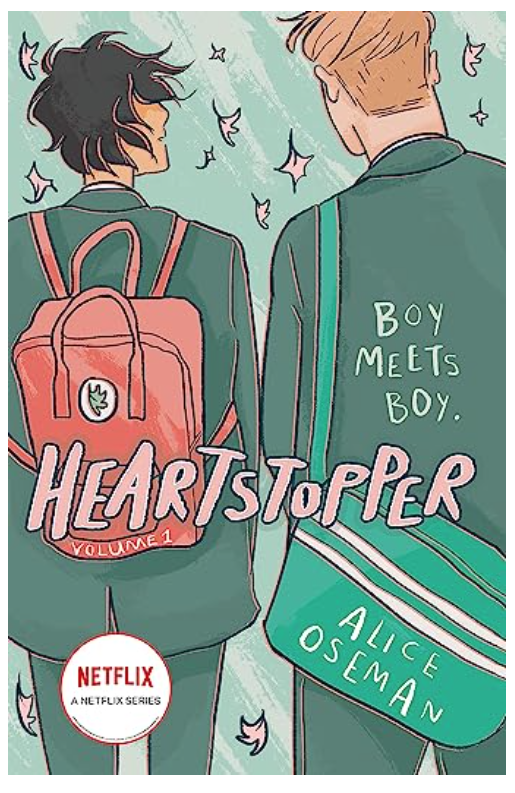Qualche giorno fa, navigando la rete, mi è passata sotto gli occhi una citazione di Judy Heumann, tratta dal suo memoir, che diceva: “Part of the problem is that we tend to think that equality is about treating everyone the same, when it’s not. It’s about fairness. It’s about equity of access”. Se avessi letto questa frase una ventina di anni fa probabilmente avrei fatto molta fatica a capirla.
Quando ero più giovane, desideravo con tutte le mie forze essere trattata esattamente come tutti gli altri. Questa volontà, però, non si traduceva mai in un cambiamento dell’ambiente esterno, ma finiva per manifestarsi attraverso una distorsione dei miei comportamenti e della mia essenza, che spesso coincideva con la cancellazione simbolica della mia disabilità. E per molto, moltissimo tempo, ho creduto fosse giusto così.
Non è un caso se oggi quando parlo del mio percorso di consapevolezza, lo associo un po’ alla reazione di chi per tanto tempo ha creduto a cose che poi si sono rivelate delle enormi bugie. Ecco, la bugia più grande per me è stato vivere senza conoscere l’abilismo. Oggi il mio impegno più grande è legato alle storie, perché queste hanno il potere di arrivare a tante persone e velocizzare quel processo di comprensione dei sistemi di potere che io ci ho messo trent’anni a capire.
Da troppo tempo, in qualità di scrittrice e osservatrice critica di prodotti audiovisivi, mi trovo di fronte a una rappresentazione della disabilità che va ben oltre la semplice inadeguatezza; è, a mio avviso, l’espressione di un fallimento culturale più profondo.
Nel panorama italiano mi sono scontrata spesso con narrazioni che hanno sistematicamente ridotto i personaggi con disabilità a stereotipi degradanti. Queste rappresentazioni li dipingono come oggetti di pietà o, “nel migliore dei casi”, come fonti di ispirazione superficiali, senza un’autentica comprensione della loro realtà. Ma perché non si riesce a uscire da questo paradigma?
 Chiunque scriva per mestiere conosce il viaggio dell’eroe, la struttura narrativa ampiamente utilizzata per scrivere storie, nata concettualmente da Joseph Campbell e successivamente elaborata da Christopher Vogler nel suo libro “The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers”.
Chiunque scriva per mestiere conosce il viaggio dell’eroe, la struttura narrativa ampiamente utilizzata per scrivere storie, nata concettualmente da Joseph Campbell e successivamente elaborata da Christopher Vogler nel suo libro “The Writer’s Journey: Mythic Structure for Writers”.
Da quando ho cominciato a scrivere, mi sono interrogata a lungo su come una struttura di questo tipo potesse essere applicata a protagonisti e protagoniste con disabilità. Leggendo “Eroine” di Marina Pierri, ho appreso che lo stesso Joseph Campbell non considerava le donne viaggiatrici, ma meta. Non posso quindi fare a meno di domandarmi se nella costruzione del viaggio eroico non ci siano altri cortocircuiti escludenti che vengono costantemente applicati anche ad altre identità marginalizzate.
L’applicazione del viaggio eroico al contesto della disabilità apre un affascinante territorio di esplorazione narrativa. In questo percorso, la disabilità non dovrebbe essere un elemento di sfondo ma concepita come parte integrante dell’identità del personaggio. Eppure la maggior parte delle storie che riguardano questo tema considerano la disabilità o come innesco narrativo del conflitto, o come prova da superare. Nella creazione di un personaggio con disabilità – il quale inevitabilmente si confronta con numerosi condizionamenti – risulta poco realistico escludere l’abilismo dall’arco narrativo. Per sfuggire a questa trappola è necessario posizionare la disabilità all’interno di una prospettiva politica e sociale.
In un’epoca che si vanta di essere progressista e inclusiva, trovo quindi insensato che le persone con disabilità continuino a essere assenti dall’intero processo produttivo. La tendenza a raccontare storie di marginalizzazione senza affidare la narrazione a chi realmente vive quella marginalizzazione, è un paradosso per me inconcepibile.
Sono consapevole che l’industria audiovisiva rappresenta già di per sé uno spazio elitario e che quindi raggiungerlo – per chi già normalmente fa fatica a raggiungere qualunque ambiente lavorativo escludente – è molto arduo e complesso. Sono però convinta che un cambiamento sia necessario e possibile, a partire dalla formazione fino al coinvolgimento di figure professionali in veste di consulenti, nell’attesa che sempre più persone con disabilità possano formarsi in questo settore. La consulenza, però, non deve rappresentare un escamotage che ha il solo scopo di proteggersi da un lavoro di decostruzione. Avere come consulenti persone con disabilità che non hanno esperienza di scrittura e/o sceneggiatura, o che non hanno una visione politica e sociale della disabilità serve a ben poco, perché la vera sfida non è essere rassicurati, ma mettersi alla prova sulle proprie convinzioni.

E se da un lato promuovere il coinvolgimento delle persone con disabilità nell’off-screen risulta difficile, l’accesso all’on-screen non è da meno. Mentre i paesi anglofoni iniziano ormai a considerare inammissibile la simulazione del corpo disabile come performance attoriale, in Italia questa è una pratica ampiamente diffusa.
L’obiezione maggiore che mi viene sollevata ogni volta che critico questa scelta, è che gli attori dovrebbero poter interpretare qualsiasi ruolo, perché immedesimarsi in altre vite è il cuore di questo mestiere. C’è però un tassello che sfugge in questo ragionamento, perché se è indiscutibile che il fulcro della recitazione sia calarsi nei panni dell’altro, questo è vero solo finché non coinvolge elementi identitari del corpo.
Oggi la maggior parte delle persone considera inaccettabile modificare l’aspetto di un’attrice o un attore per fargli interpretare un personaggio di un’altra etnia. In passato questa pratica, conosciuta come whitewashing, era piuttosto diffusa e oggi viene universalmente riconosciuta come discriminatoria. Eppure, quando pratiche simili coinvolgono il corpo di altre identità non si solleva alcuna critica, anzi, il più delle volte la performance viene acclamata.
La disabilità non è un costume che puoi indossare e toglierti a fine giornata, non è un trucco, non è una maschera. La disabilità è un’identità che merita rispetto al pari di tutte le altre. Da sempre simulando i nostri corpi si viene considerati interpreti eccezionali, si vincono premi e riconoscimenti, e intanto numerosi attori e attrici con disabilità di talento non vengono scoperti o rimangono nell’ombra.
Sono più che consapevole che il percorso verso il cambiamento sia una strada in salita. Tuttavia, riconoscere l’importanza di avere persone con disabilità nell’intera filiera dell’industria audiovisiva è un passo fondamentale. Non si tratta solo di dare spazio a queste voci, ma di riconoscerle come elementi essenziali nelle storie, per avere narrazioni che rispecchino davvero il mondo e tutte le persone che lo abitano.
[Foto di Pawel Czerwinski]