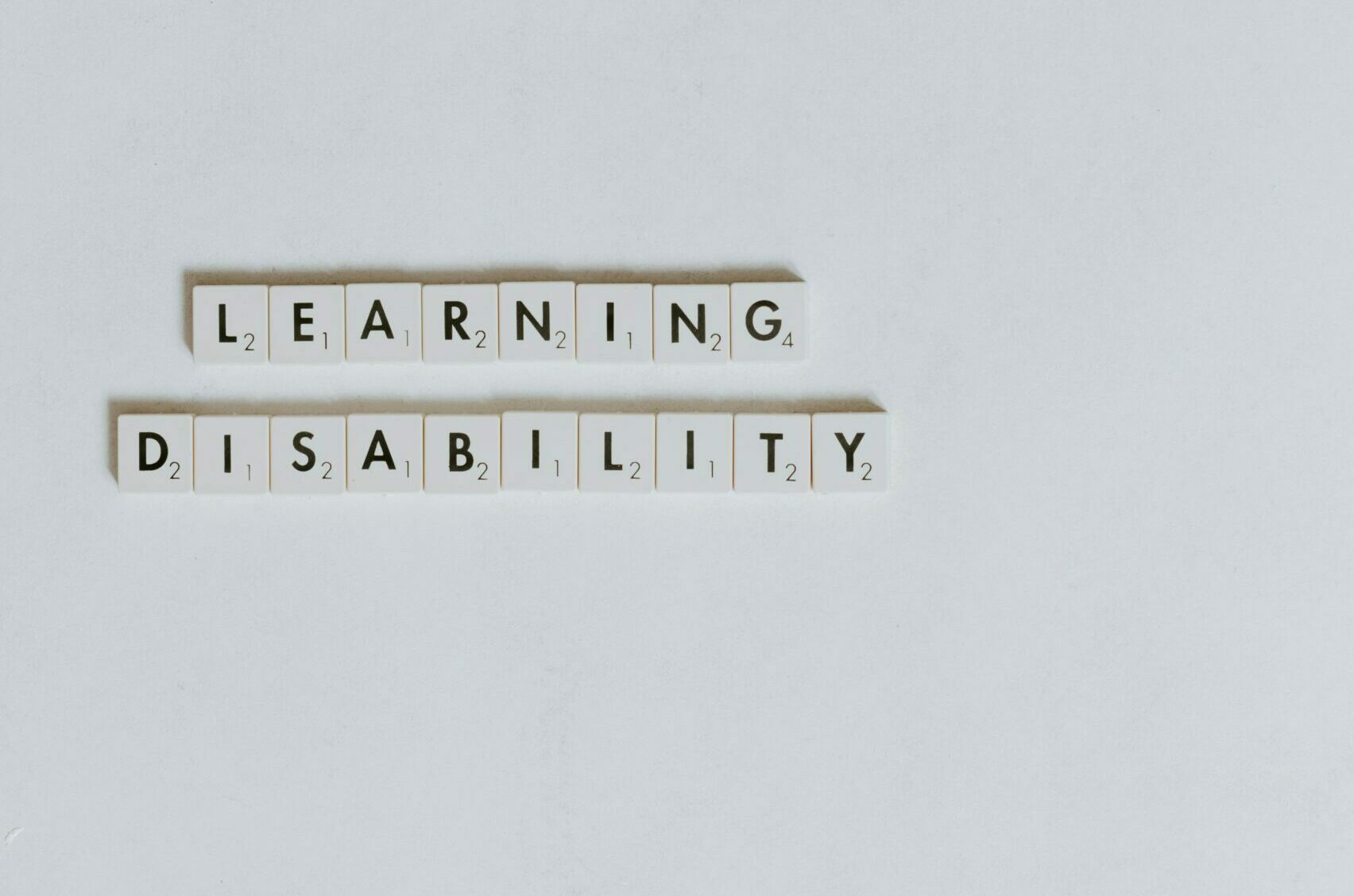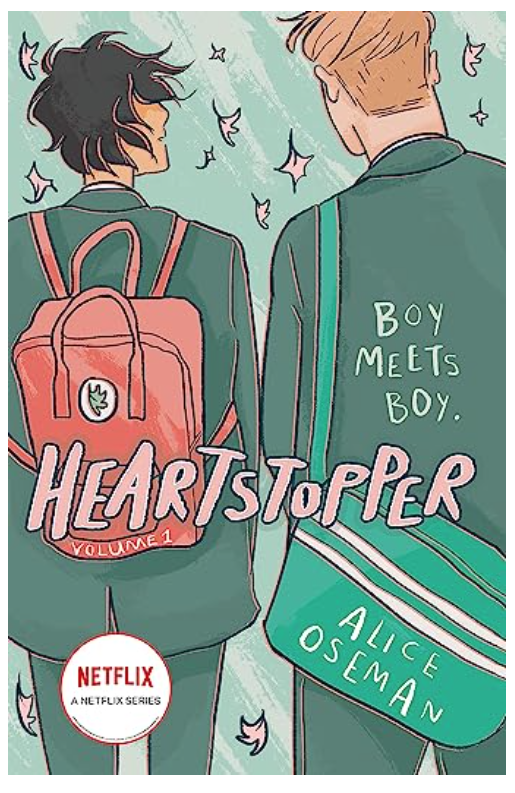Ricoprire il ruolo di sindacato studentesco richiede grande conoscenza e presenza quotidiana all’interno dei luoghi del sapere, quali le scuole e le università del nostro Paese. Spesso è scoraggiante constatare quindi quanto gli spazi che ci accolgono fin da piccoli e che sono pensati appositamente per farci crescere, abbiano ancora tanti passi da fare per comprenderci davvero. Un po’ come fossero dei mobili antiquati che non evolvono e si presentano austeri ed inospitali.
Ho vissuto e sto attualmente vivendo questi luoghi, così come tante altre compagne hanno fatto e continuano a fare, senza rendermi inizialmente conto di come questi influenzassero il mio modo di guardare il mondo, percepire me stessa e comportarmi all’interno della mia stessa comunità.
Se vogliamo iniziare subito la discussione, perché di questo si deve trattare se immaginiamo un percorso di cambiamento che parta dal basso, con una tematica attualmente scottante, basta fare riferimento alla scelta linguistica che vede professori, docenti, ricercatori, studenti e assistenti come parte unicamente del genere maschile, mentre il ruolo della maestra, in stretta connessione con i bimbi più piccoli, difficilmente si addice, nell’immaginario comune, ad un uomo.
La recente scelta dell’Università degli studi di Trento di ricorrere al femminile universale, per fare un esempio che riprenda l’attualità, è al centro di diverse polemiche, pur non essendo che un piccolo passo intermedio, e forse a questo punto mi viene da definire tristemente precoce, per una società non ancora pronta ad ammettere di avere un grande problema con il riconoscere ed affrontare la presenza nei propri spazi di discriminazione di genere, rendendo impensabile anche solo una svolta a livello semantico nella nostra vita di tutti i giorni. Rivolgersi al personale della scuola o dell’università utilizzando sostantivi di genere femminile, infatti, non soddisfa ancora la comprensione delle diverse soggettività che di questi luoghi fanno parte, ma quantomeno è un tentativo di superamento di abitudini ormai antiquate e stantie che è tempo di lasciarsi alle spalle e che continuano a creare gravi danni in tema di educazione alla cittadinanza, al rispetto e all’inclusione.
A chi non è capitato, inoltre, nel proprio percorso di studi di leggere, durante gli accesi periodi di campagna elettorale pre elezioni di rappresentanza studentesca alle scuole superiori, volantini e programmi di liste che promettessero di realizzare feste d’istituto di indicibile portata, eludendo coprifuochi, distraendo dallo studio e magari inserendo un banchetto di vendita dolci, che attira tendenzialmente positivamente l’attenzione dei giovani elettori e delle giovani elettrici? Tante energie impiegate nella strutturazione di questi eventi e al contempo poca, pochissima attenzione cosa questi stessi eventi possono rivelarsi. Non è stato raro, nei miei anni di studentessa, sentire, assistere e vivere episodi di molestia, discriminazione e violenza di genere proprio in occasione di quella che si promette e dovrebbe essere una festa dedicata alla comunità studentesca tutta, al riparo da ansie, stress, preoccupazioni e timori. Eppure anche i momenti conviviali di questo tipo rientrano nell’idea di un ambiente scolastico e di una cultura di fondo che non protegge le nuove generazioni, che non prevede una tipologia di supporto come degli sportelli di ascolto, un servizio sicurezza formato o un referente del caso potrebbero nel loro piccolo fornire alle studentesse che si trovassero a vivere situazioni di disagio e difficoltà di questo tipo. La cosa più preoccupante di tutto ciò è che non ci sia la minima intenzione di farci comprendere quanto questo tipo di attenzione sia necessaria ed importante.
A questa constatazione si ricollega in maniera evidente una problematicità di fondo: non abbiamo gli strumenti per riconoscere, combattere e soprattutto prevenire dinamiche di prevaricazione e violenza di genere, termini che comprendono al loro interno una vasta gamma di abitudini, gesti, parole, scelte che come esseri umani compiamo ogni giorno, senza neppure renderci conto della loro inopportuna e malsana matrice patriarcale.
Siamo abituate fin da subito a prendere parte a percorsi di educazione all’affettività che rispecchiano schemi fortemente ed univocamente binari, che elevano e sostengono la concezione di passatempi, lavori e comportamenti che riconducano in maniera inequivocabile ad uno specifico genere. Viviamo la sessualità come un tabù, le mestruazioni come una vergogna, l’amore come un rapporto gerarchico. Questa impostazione di fondo ci impedisce poi di percepire come necessari strumenti che, al contrario, permetterebbero alle nostre scuole di essere un luogo sicuro per tutte e tutti, come l’introduzione delle cosiddette carriere alias nelle scuole, ossia la possibilità di modificare sui documenti non ufficiali il nome assegnato alla nascita per persone non binarie o con disforia di genere, o anche il funzionamento garantito di servizi inestimabili come il sostegno psicologico e gli sportelli d’ascolto, consultabili in orari e con disponibilità che permettano a chi ne senta il bisogno di farvi ricorso e trovarvi un supporto reale.
A prima vista sembrano soluzioni distanti dal tema del transfemminismo e invece sono parte di un processo di inclusività, attenzione e cura a livello intersezionale che ha tutto a che vedere anche con la lotta alla violenza di genere, che sempre più minaccia ogni fascia d’età e ogni ambito comunitario, trovando attualmente nella scuola la sua matrice genetica piuttosto che un presidio pronto a smontare tutto ciò che possa sostenere e dare vita ad un sistema machista e pericoloso per chiunque ci viva, nello specifico per le persone socializzate come donna.
Per raggiungere davvero un modello di scuola definibile come “transfemminista” c’è bisogno della voce di una comunità studentesca ad oggi sempre più relegata ai margini delle discussioni, dei tavoli di lavoro e delle riforme che la riguardano.
Proprio per questo motivo, inoltre, illudersi che l’unica mancanza attualmente presente a livello di parità di genere nella scuola italiana riguardi il non parlare delle figure femminili importanti nella storia, arrivando quasi a cancellarle – posto che questa scelta didattica evidenzia un altro aspetto tristemente retrogrado della nostra cultura – non farebbe che relegare la questione del transfemminismo nei luoghi del sapere ad una lista enciclopedica di donne che ce l’hanno fatta e sono riuscite a farsi conoscere e ricordare nonostante il loro essere parte del sesso debole. Penso sia evidente come, in realtà, questa sia una visione parziale e stigmatizzante che dobbiamo imparare a superare.
I luoghi del sapere e di formazione della persona, per quanto imparziali possano essere, non dovrebbero dunque per nessun motivo rifuggire il mondo della politica ideologica perché, se avere i piedi per terra ed essere realistici è alla base della nostra sopravvivenza come specie, l’appiattimento culturale e creativo a cui assistiamo giorno dopo giorno in ottica di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita politica del nostro Paese impedirà per sempre a studenti e soprattutto studentesse di riconoscere le mancanze nel proprio percorso di studi, di immaginare un luogo davvero sicuro e di alzare la testa con la consapevolezza di poterlo richiedere.
Dunque, che la lotta per i diritti delle donne non si fermi a una visione che comprenda in maniera più ampia quelle che siamo abituati a definire minoranze, perché generalmente marginalizzate, ma che si estenda al coraggio di utilizzare il potente strumento dello studio anche per cambiare ciò che da troppo tempo siamo abituati a ritenere normale, a partire dagli spazi che viviamo e condividiamo ogni giorno.
Camilla Rugolotto – Rete degli Studenti Medi