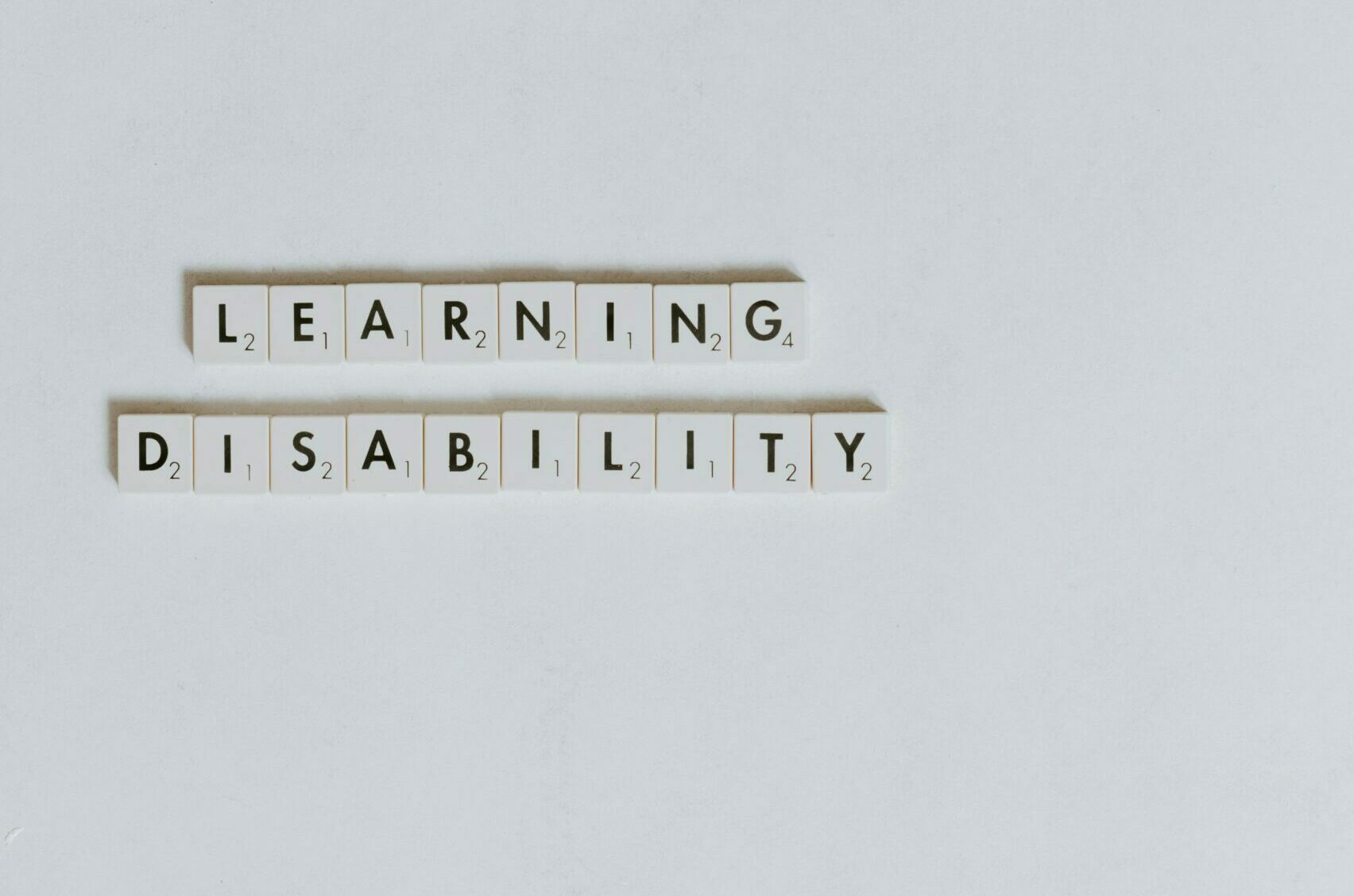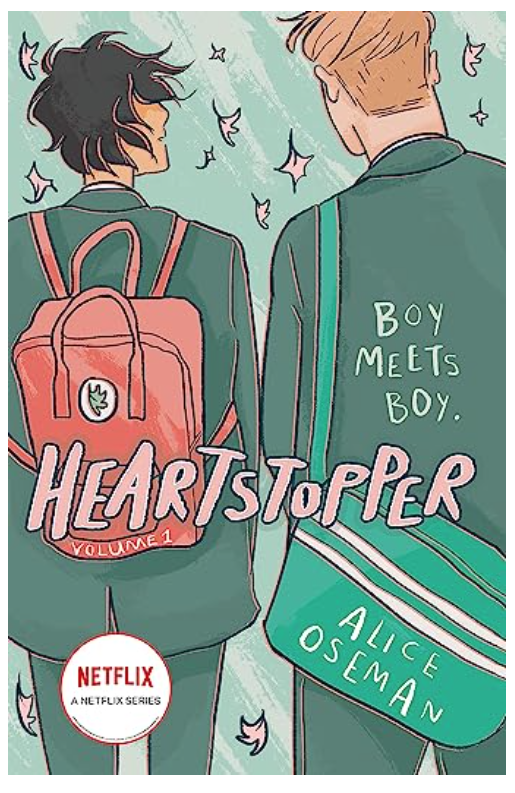“Sei fortunato a essere nato in Italia”. Mi è capitato spesso di sentire queste parole, talvolta dalla bocca dei miei parenti tunisini, altre volte da chi cercava in qualche modo di analizzare le origini del mio nome. Sono nato e cresciuto in un paese in cui il senso di “comunità” tende a differire dalle reali intenzioni di chi ci abita. La comunità, nel senso più lato, si accorda alla religione, alle buone maniere, alla cucina. E fin qui, nessuno può azzardare una definizione contrastante: l’Italia è un paese unito dalle tradizioni, da usi e costumi che però hanno la tendenza a voler lasciare le cose come stanno. I cambiamenti spaventano, soprattutto in quelle ampie categorie sociali che investono il “senso comune”, a discapito di un senso meno unidirezionale. Le comunità – da quelle lgbtqia+ a quelle più strettamente legate alla cultura altra – si mantengono con l’appoggio di chi cerca in qualche modo di diversificare la società.
“Sei fortunato a essere nato in Italia”. Mi è capitato spesso di sentire queste parole, talvolta dalla bocca dei miei parenti tunisini, altre volte da chi cercava in qualche modo di analizzare le origini del mio nome. Sono nato e cresciuto in un paese in cui il senso di “comunità” tende a differire dalle reali intenzioni di chi ci abita. La comunità, nel senso più lato, si accorda alla religione, alle buone maniere, alla cucina. E fin qui, nessuno può azzardare una definizione contrastante: l’Italia è un paese unito dalle tradizioni, da usi e costumi che però hanno la tendenza a voler lasciare le cose come stanno. I cambiamenti spaventano, soprattutto in quelle ampie categorie sociali che investono il “senso comune”, a discapito di un senso meno unidirezionale. Le comunità – da quelle lgbtqia+ a quelle più strettamente legate alla cultura altra – si mantengono con l’appoggio di chi cerca in qualche modo di diversificare la società.
Nascere e crescere in Italia con un padre tunisino e una madre italiana ha spesso fatto di me un soggetto al limite. Il problema dei soggetti al limite è che vengono posti a tal livello perché continuamente in cerca di definizione. E se non volessi una definizione? E se mi piacesse l’idea di essere un po’ italiano e un po’ tunisino?
Sono cresciuto ad Andria, paese che vuole dirsi città e in cui ho spesso trovato rassicurazioni, altre volte grandi sfide identitarie. In quegli anni, parole come “nuovi italiani” e “seconde generazioni” erano poco utilizzate a scuola, e per questo motivo si adoperavano usi più espliciti, come “diverso” o “africano”. Ricordo con assoluto dispiacere la mia prof di lettere, che dall’alto della sua borsa Prima Classe e il caffè macchiato che aleggiava in classe, si divertiva a trovare ogni giorno una diversa definizione da darmi. Ammetto che a un certo punto ci si adatta, un po’ come atto di autoconservazione: “D’accordo, non sono completamente italiano, e allora?”. Ciò che però mi infastidiva era un discorso ben più esteso, legato alle esigenze economiche. Avere un padre tunisino significava essere uno studente povero. Spesso, erano gli stessi professori a denunciare le mie ipotetiche incapacità economiche: “Non riesci a comprare delle tempere migliori?” o “Quando ti arrivano i libri scolastici?”. Attenzione: non ero uno studente povero, neanche ricco, vivevo la stessa situazione di altri compagni di classe. Avevo bisogno di attendere la cedola scolastica per acquistare i libri, o le tempere costose. È in quel preciso momento della mia vita che ho compreso quanto sia difficile poter essere “normali”.

Oggi vivo a Palermo, il mio nome è sempre lo stesso. Capita di giustificare le mie origini, nulla di così debilitante. Ma continuo ad avvertire quel senso di superiorità da parte di chi – indipendentemente dal proprio credo politico – è convinto di avere il mondo tra le mani. Ma io che sono una persona molto fantasiosa non posso far altro che notare tra quelle mani una borsa costosa, un pacchetto di caramelle per l’alito e tanta malinconia. Le maggioranze e le minoranze continuano a lottare contro un punto comune, quando sarebbe più semplice cercare un’unione che possa permettere somiglianze. Essere di seconda generazione vuol dire lottare prima con se stessi, comprendersi, accettarsi, poi sfidare il mondo, non arrendersi, sperare. E forse è proprio quella povertà che ti viene attribuita a renderti più umano.
È tutta una questione di intenti, e forse anche di cuore.