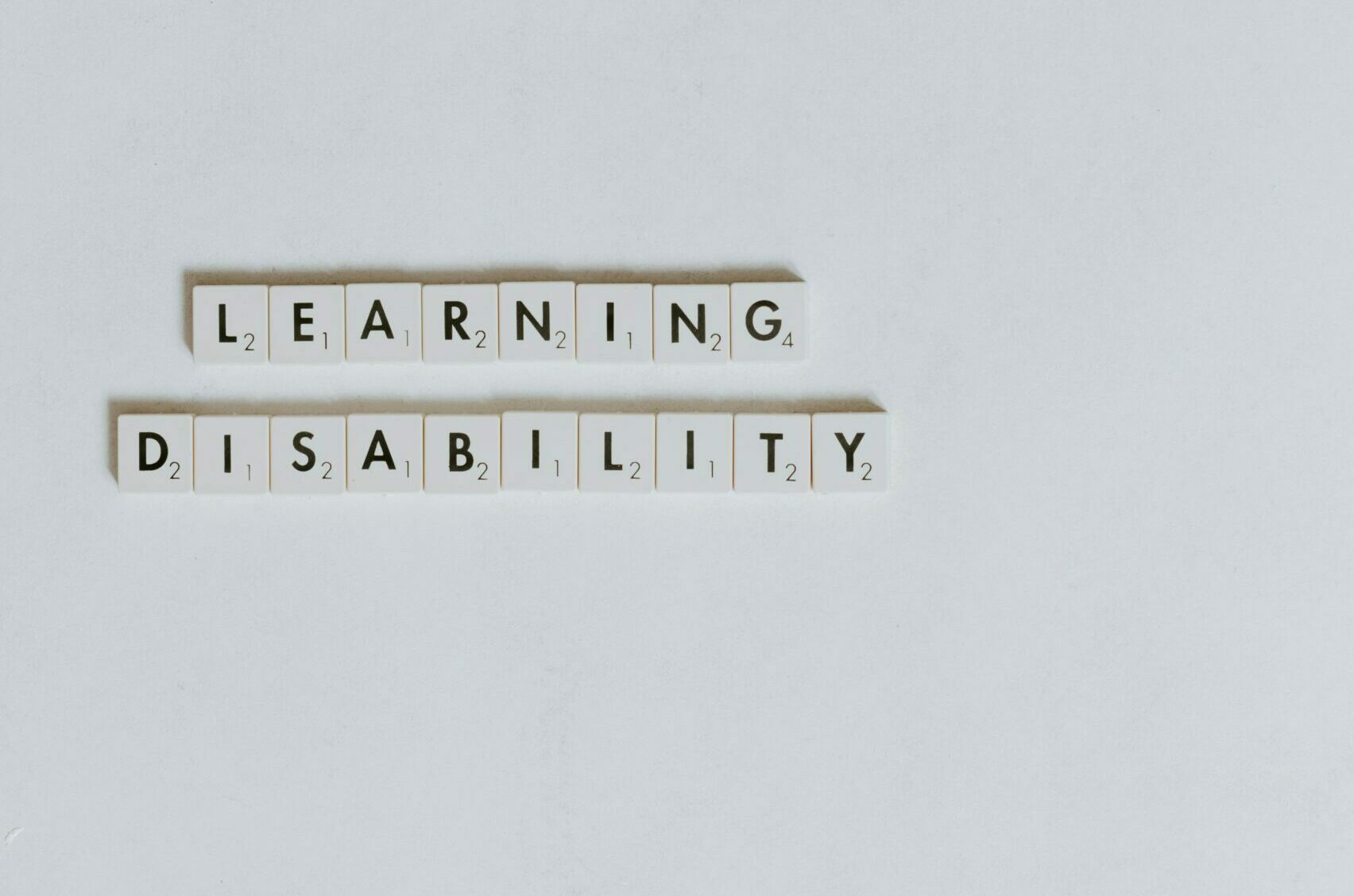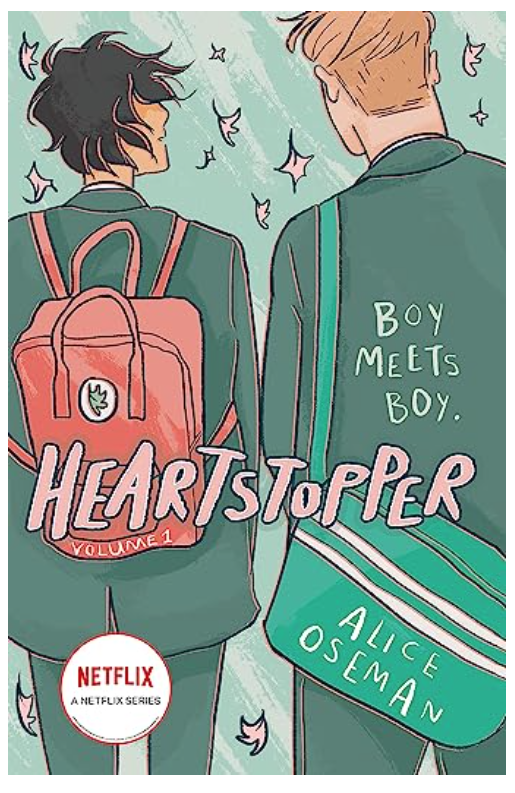A New York la parola “successo” è ovunque. Nei cartelloni pubblicitari, nei jingle dei commercials, nelle conversazioni ai tavolini dei caffè. Una parola così abusata, così costantemente reiterata, da generare una sottile forma di colpa esistenziale in chi, come me, ha scelto un percorso meno canonico.
A New York la parola “successo” è ovunque. Nei cartelloni pubblicitari, nei jingle dei commercials, nelle conversazioni ai tavolini dei caffè. Una parola così abusata, così costantemente reiterata, da generare una sottile forma di colpa esistenziale in chi, come me, ha scelto un percorso meno canonico.
Ho seguito mio marito a New York — lui sì, per un lavoro di successo. Lo dico con stima e affetto: Edu è mio marito, il mio compagno di vita, l’uomo che ho scelto di sostenere, come ho sempre fatto, e come lui profondamente merita.
Quanto a me, ho cinquantotto anni. A un certo punto ho lasciato il lavoro e ho deciso di dedicarmi interamente al benessere della nostra piccola famiglia — che comprende, oltre a noi due, anche due cagnoline di piccola taglia. Alcuni le chiamano “pets”. Noi preferiamo “le bambine”.
Quando mi chiedono di cosa mi occupi, rispondo sinceramente: mi prendo cura di noi. Cucino, compro piante, faccio dolci vegani. In cuor mio, mi preparo a ricevere uno sguardo imbarazzato, magari compassionevole. Invece, ciò che ricevo più spesso è qualcosa di sorprendente: ammirazione.
In questa città che misura tutto in metri quadrati, dollari e lifestyle, risulto essere — mio malgrado — un uomo di successo. Ho sposato un uomo benestante, vivo in un appartamento ampio e luminoso a Carroll Gardens, quartiere molto ambito da chi può permettersi il lusso di essere “alternativo”. Possiedo una carta di credito che non rifiuta mai.
E allora, la domanda antica — da buon europeo esistenzialista — ritorna con forza: da cosa dipende, oggi, il valore della vita umana? Qui la risposta sembra semplice, quasi brutale: dal tuo potere d’acquisto. Ma non è tutto. Molti amici e parenti, da entrambe le sponde politiche (perché sì, se Meloni ha vinto, significa che anche tra chi ci è vicino qualcuno l’ha votata), mi chiedono come venga percepito Trump, qui. Non sono un sociologo, ma una cosa l’ho capita. In una società dove il successo personale è un imperativo morale, nessuno vuole essere l’escluso, l’outcast. E così si cerca chi sta più in basso, qualcuno da indicare come il vero fallito, l’anomalia, l’altro da sé.
Accade così che nel complesso pacchetto del voto, persone gay votino contro i diritti delle persone trans, che messicani e cubani rigettino gli immigrati di nuova generazione, che afroamericani si schierino contro chi riceve sussidi statali. Che alcune donne si proclamino “portatrici di vita” e combattano le femministe pro-choice.
E poi ci sono loro: i white trash, l’America dimenticata, quella che per anni si è sentita costretta a digerire principi progressisti e fiabe con principesse nere e donne con il pisello entrare nello stesso bagno delle mogli. Oggi si sente ascoltata. Rivendica il diritto di tornare a discriminare apertamente, di riaffermare un’idea di mondo che credeva perduta.
Trump non ha vinto perché è un politico. Ha vinto — e continua a farlo — perché incarna un’idea potente: è l’uomo che “ce l’ha fatta”. In un’America dove forza e ricchezza sono i passaporti per la libertà assoluta (una libertà anarchica), lui rappresenta la versione estrema e seducente del sogno americano. Una libertà non collettiva, ma individuale. Una libertà che si misura, esattamente come dicevo prima, in metri quadri, in follower e, soprattutto, in saldo disponibile.
E da Carroll Gardens, per questa prima “puntata”, è tutto.
🎧 [Per goderti meglio questa rubrica e avere un’esperienza più immersiva, ascolta questa playlist ideata dallo stesso autore: THE BROOKLYN SUN]