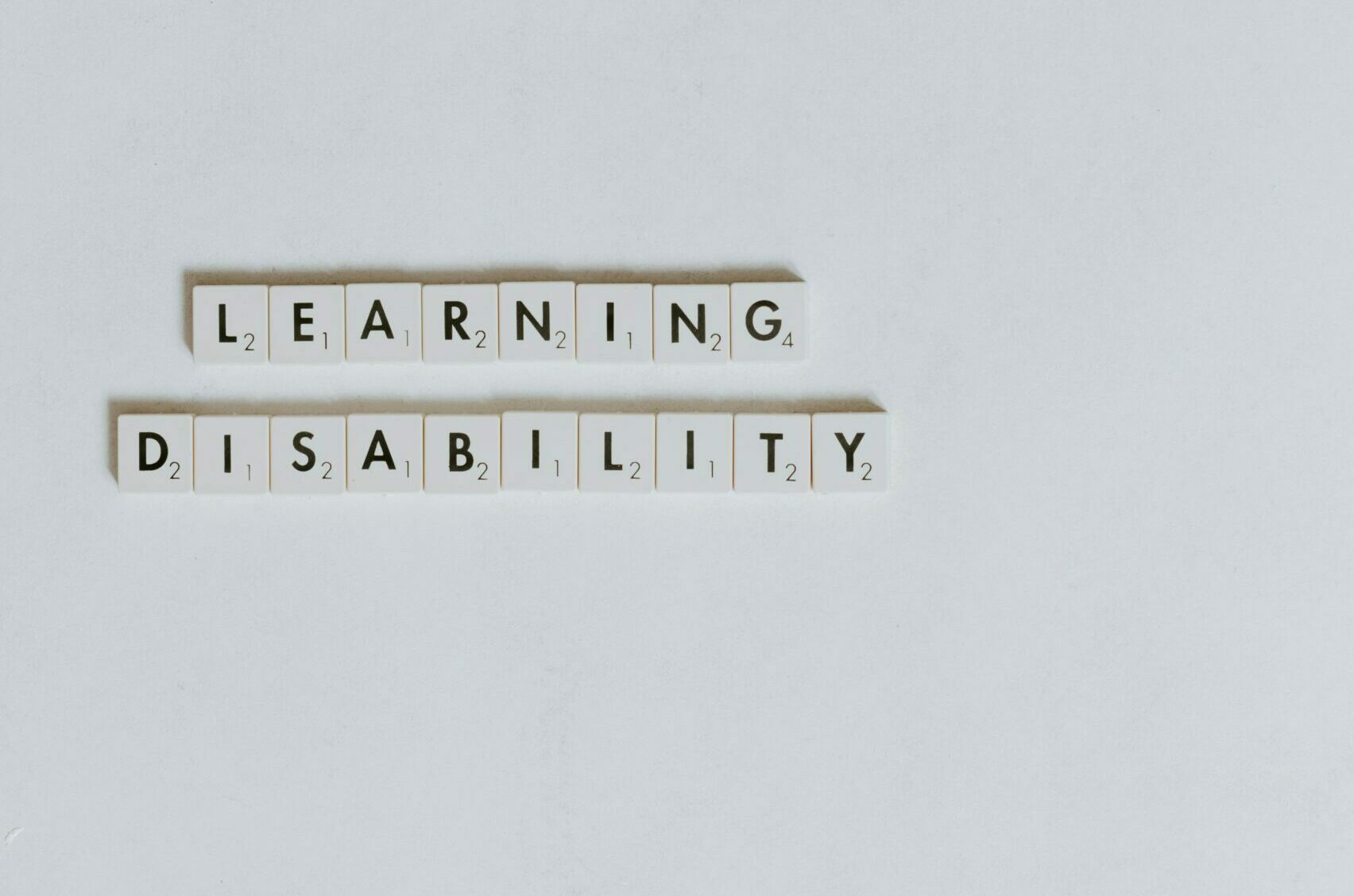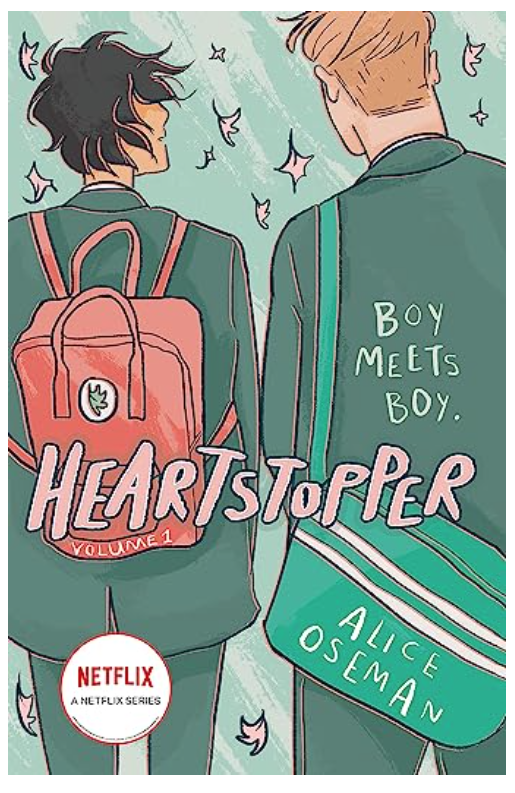La comunità lgbtiqia+ è costretta a parlare la lingua dell’eteronormatività. Il linguaggio che usiamo per parlare dei nostri corpi, delle nostre relazioni e del nostro sesso non conforme è quello della conformità. Come si può raccontare in modo autentico la nostra realtà se gli strumenti che abbiamo per farlo l’aboliscono? Se non ci forniscono le parole, le regole grammaticali che non prevedono la nostra esistenza?
Il linguaggio lgbtqia+, e soprattutto il linguaggio queer, partono azzoppati in partenza da una lingua che ci disprezza apertamente, ma che siamo obbligati a usare a patto di esistere in questo mondo.
Storicamente, la risposta è stata quella dell’hackeraggio linguistico: le parole create per umiliarci sono spesso diventate le parole del nostro orgoglio. Usiamo gli insulti più feroci – che uniscono in mille linee oppressione di classe, sex worker, specista e omolesbobitransfobica – come saluti affettuosi dandoci delle troie, delle vacche, dei ricchioni, delle frocie.
L’insulto trasformato in linguaggio di intimità rimane uno degli strumenti più forti della rottura con la Lingua Normata. Poiché il sistema ciseteropatriarcale non solo divide in uomini e donne, ma in bravi uomini e brave donne, l’insulto non solo stravolge la divisione binaria uomo/donna, ma anche quello del contenimento della non conformità sessuale.
Parole risemantizzate, parole rivendicate, parole nuove. “Vi inventate sempre nuove parole” è l’accusa più diffusa e fessa mai fatta alla comunità lgbtqia+. Ho sempre trovato curiosa l’accusa di innovazione, per quanto mi sia chiaro che il problema tacitato sia piuttosto che non viene da un loro sistema valoriale. In generale, la novità è quello che fa pisciare sotto la Norma in una società che ha fatto dell’immobilità – anche definita tradizione – un valore. La rottura del paradigma, della norma e dunque del cambiamento è invece non solo qualcosa a cui aspirare ma una pratica politica. Anche attraverso il cambiamento e sovvertimento del linguaggio pratichiamo la nostra dissidenza.
Perciò creare nuove parole non solo è possibile, ma necessario.
Un esempio sono le parole che definiscono orientamenti e identità come pansessuale, aromantico, asessuale, agender, bigender. Creare una parola in cui le persone possano identificarsi può essere un atto di visibilità e di emersione imprevista nel panorama delle cose nominate. Creare linguaggio non crea la realtà, ma può renderla visibile.
Nel tempo abbiamo giocato con i pronomi, da prima dell’emergere della schwa o nella desinenza neutra -u. Ci definivamo e chiamavamo al femminile, tutte indistintamente, perché quello in un sistema solo binario era il genere delle ultime, delle deboli e delle emarginate. Il femminile è stato – ed è largamente ancora – il pronome della sovversione dell’universale. Un universale che si finge neutro, ma che hai connotati del maschile.
Questo nonostante i gay cis lo abbiano spesso utilizzato per differenza più che per effettiva rivendicazione: gli uomini gay cis, seppur gay, che normalmente utilizza pronomi maschili, quando compie il salto di identificare il sé con l’altra, lo fa solo in ottica performativa. Nello slang gay del darsi della pazza, al femminile, rivendica una non conformità che però comunque identifica l’estranea, cioè l’altra, con il femminile. Aderisce perciò comunque alle regole binarie di un linguaggio maschile-femminile dove il femminile vale meno. Perché i verbi e le parole che declinano al femminile per nominarsi sono tutte parole a sfondo sessuale, denigratorio o in termini di salute mentale. Pazza, sfranta, piena, rasa.
Le donne lesbiche, le donne trans* e le persone non binarie, invece, utilizzano da molto tempo forme come il femminile sovraesteso per un’emersione del potere affermativo del femminile. Quella che negli anni ‘70 era una pratica molto potente dei gruppi lesbici separatisti, che negli ultimi tempi sta trovando elementi di assorbimento da parte della Norma: utilizzare un femminile sovraesteso non cambia il problema, per esempio, che il gruppo delle dirigenti possa essere tutto di uomini. Il rischio della strumentalizzazione da parte del linguaggio egemone per una finta equità tuttavia trova nella dissonanza un elemento comunque sovversivo fintanto che gli uomini etero cis proveranno disagio sociale nell’essere chiamati al femminile o nel sentirsi cancellati nell’utilizzo del femminile sovraesteso.
Il linguaggio neutro ha provato a proporre nuove mappature che scardinassero il maschile universale: ovvero l’occupazione coatta dei nostri corpi dall’idea che il maschile è lo standard. Lo standard è l’architettura invisibile che caratterizza ogni costrutto. Lo standard è tale perché è indiscutibile, ma non è neutro. Per questo pensare a forme come la schwa o la terminazione -u oppure all’utilizzo dell’asterisco sono tutte soluzioni di linguaggio che provano a scardinare il maschile egemone.
Poche cose hanno indignato come la schwa&affini perché a differenza della risemantizzazione di parole vecchie e della creazione di parole nuove con regole grammaticali vecchie, queste soluzioni linguistiche non contemplano una genealogia patriarcale. In altre parole, non si appoggiano al sistema attualmente in uso, a etimologie greche e latine, ma ne inventano uno nuovo. Queste soluzioni sono poco concilianti con il linguaggio normato – e dunque considerato normale – e creano confusione linguistica perché mettono quantomeno in discussione le regole. La cosa più interessante della schwa e dall -u è che creano disagio: le persone ridono nervose, s’arrabbiano, si giustificano, si sentono frustrati e inadeguati. Stati emotivi che solitamente appartengono alle persone marginalizzate.
L’uso grammaticale di queste soluzioni è caotico: la comunità lo usa in modo prevalente, anche senza osservarne le effettive regole grammaticali. La qual cosa è tremendamente queer. Allo stesso modo questi linguaggi hanno ottenuto una reazione – ostile – della società. L’Istituto della Crusca e alcuni linguisti si sono scagliati contro la Schwa & altri rimedi parlando di coerenza linguistica e storia della lingua italiana.
Non mi interessa confutare queste accuse – che comunque non stanno in piedi – perché non mi aspetto né cerco il consenso all’uso da istituzioni che conservano uno status quo che voglio rovesciare.
Nonostante le petizioni, gli articoli e le interviste alla tv, le forme di linguaggio neutre sono lingua viva: vengono utilizzate nella comunità, sui materiali informativi, nei tiktok, nei caroselli, nelle assemblee e anche nei libri di testo.
L’utilizzo di linguaggi neutrali e non binari ha avvistato una nuova terra del linguaggio queer, così come il pronome neutro they/them e i neo pronomi. Il pronome they/them, cioè loro, non trova una semplice applicazione ad oggi, così come i neopronomi, che seguono l’idea che ci si possa inventare il proprio pronome anche giocando con il mondo fantastico: xi/xem, ze/zir e così via. Molte persone che ricorrono ai neo pronomi sono più interessate ad aprire il confronto sul tema a che vengano effettivamente utilizzati in modo corrente. L’utilizzo di pronomi non connotati di genere sono una pratica più che una soluzione linguistica: servono a rompere il passaggio automatico che ci fa ricondurre un corpo a un destino, un corpo a una parola data. Ci aiuta, cioè, a compiere l’esercizio difficile di non sovradeterminare la persona che abbiamo davanti, ma di accogliere la fluidità della natura stessa.
Usare nuovi linguaggi, tuttavia, non equivale a creare nuovi mondi. In questi termini avviene forse un fraintendimento del linguaggio lgbtqia+ e queer, vecchio e nuovo: l’enunciazione non corrisponde alla realtà. La fiducia che riponiamo nel fatto che nominare le cose le renda visibili è poco realistico. Le nostre esistenze sono, possono essere raccontate ma non ascoltate. Fa schifo, ma è un fatto.
Questa forse è la ragione per cui a tutte queste nuove soluzioni linguistiche viene risposto che sono difficili da usare o che rendono la comprensione del linguaggio ostica. Il potere legittima solo le forme di linguaggio che usa e lui può capire, scrive Brigitte Vassallo. Per questo la normazione del linguaggio queer avviene, banalmente, attraverso il ricatto sociale della comprensione e, dunque, dell’accettazione.
Il linguaggio inclusivo non mostra il reale, ma si impadronisce del caos generativo del nuovo linguaggio queer per pettinarlo in condizioni sine qua non. La sua stessa dicitura, chiaramente pensata dal Potere, configura il linguaggio come una concessione di un gruppo egemone a un gruppo emarginato, la cui inclusione può essere determinata con patti precisi. Quello di non esagerare, solitamente.
Il linguaggio queer non è politically correct né inclusivo. E’ un linguaggio vivo, rappresentativo, eccessivo.
Il corpo queer non è che non possa parlare, ma non viene ascoltato. Per essere ascoltato deve rendersi comprensibile al potere cioè usare la sua lingua. Ma questo non può essere considerato accettabile. La strada, difficile, del linguaggio queer si muove oggi in questo conflitto con la norma che sfida non con una regola, ma con una verità: il linguaggio lo fa l’uso.
Se sapremo resistere al movimento incessante di livellamento e oppressione sociale a un uso normato della lingua. Se useremo le parole per creare conflitto e dissonanza, senza temere la non comprensione, forse potremo disegnare una nuova mappatura del linguaggio.
Ad oggi appare preferibile parlare in modo generativo e caotico, e non inclusivo. Un linguaggio che può fallire e fluidificarsi, contraddirsi, espandersi. Come noi.
[Foto di Elsa Campini]