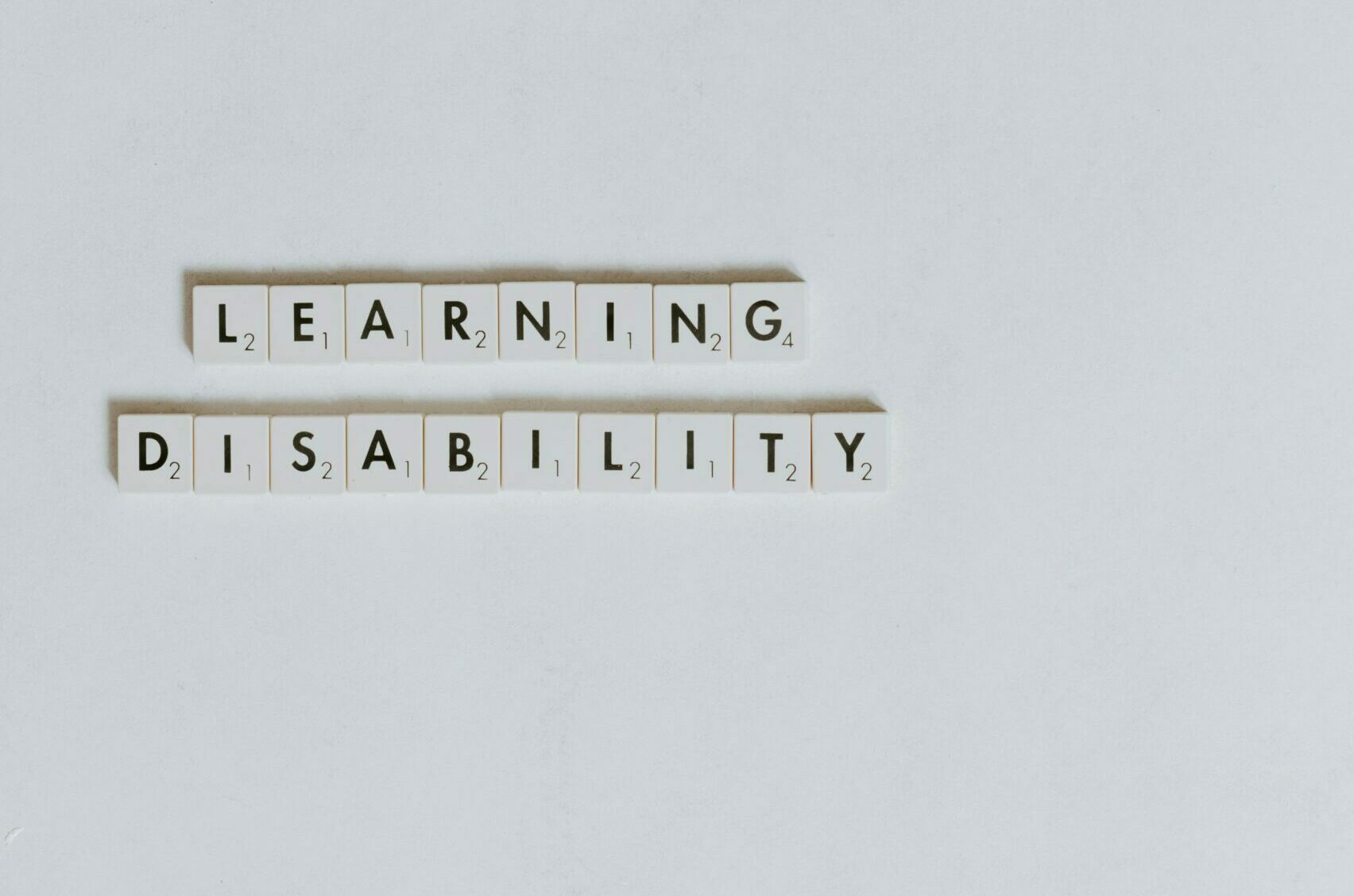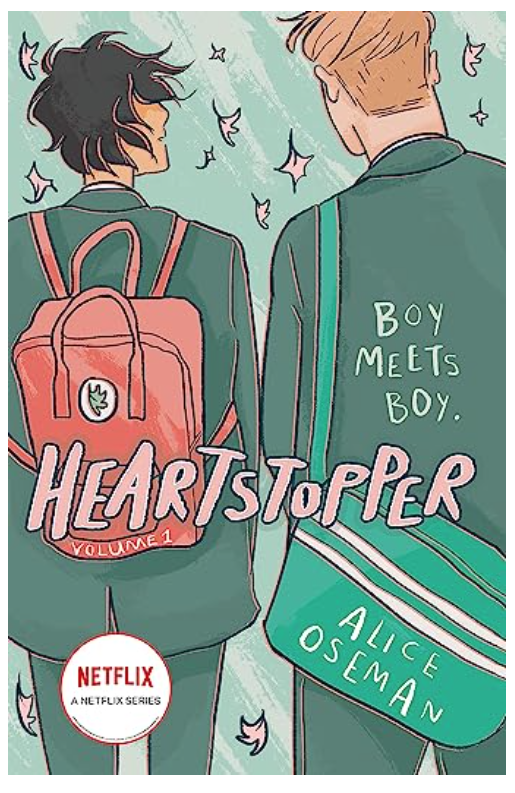“Tutte le iniziative che recuperano la nostra storia e la nostra memoria pagano un tributo a tutti coloro che non si sono piegati alla menzogna e alla negazione e che hanno scelto di impegnarsi in una lotta di liberazione ed emancipazione non solo per se stessi, ma per tutti coloro che mai ne avrebbero avuto il coraggio”.
Ho cominciato a raccogliere materiali per ricostruire la storia del movimento e della comunità lgbtqia+ italiana all’inizio degli anni Novanta. Nell’estate del 1992 mi ero recato per una vacanza negli Stati Uniti e nei primi giorni di permanenza a New York, in una libreria, avevo acquistato un libro appena uscito, intitolato Making History – The struggle for gay and lesbian equal rights, 1945-1990: an oral history, scritto da un giornalista della radio pubblica, Eric Marcus. Marcus aveva preso un anno di aspettativa e aveva girato l’America con un registratore per raccogliere le testimonianze di una serie di attivisti lesbiche e gay, grazie alle quali era riuscito a raccontare il coraggioso percorso del movimento per i diritti delle persone gaylesbiche – allora non si usava ancora l’acronimo lgbtqia+ -, partendo dalle prime timide dimostrazioni della Mattachine Society sino alle imprese più bellicose di Act Up. Quello che mi affascinò del libro era la sua stessa formula: ogni capitolo era la storia di uno degli attivisti intervistati, in forma di racconto personale. La successione di questi racconti disegnava un affresco di quei decenni di lotta, con un carico di umanità che non poteva che stimolare la più convinta empatia nel lettore. Avevo amato in particolar modo il fatto che il metodo Marcus prevedesse la raccolta anche dei ricordi d’infanzia e di adolescenza dei suoi intervistati: piccoli romanzi di formazione collocati in epoche e geografie affatto differenti dell’America del secondo dopoguerra. Divorai le 500 e passa pagine del saggio di Marcus nel giro di pochi giorni e trascorsi il resto della mia vacanza roso dalla curiosità: mi resi conto per la prima volta che non avevo alcuna idea di quale fosse stata la via italiana all’emancipazione della comunità lgbtqia+, chi ne fosse stato protagonista, quali fossero stati i passaggi salienti, quali le battaglie, quali le difficoltà, quali le vittorie, quali le sconfitte, quali gli eroi e quali i nemici. Sapevo solo che una storia di impegno e di lotta senz’altro c’era stata: intanto perché io, immeritatamente, ne godevo gli effetti – che, allora, mi sembravano già importanti e consolidati -; e poi perché avevo cominciato da un paio d’anni a scrivere come collaboratore per Babilonia, una rivista mensile di informazione e cultura omosessuale, che di quel processo di emancipazione e liberazione era evidentemente uno dei risultati.
Nel 1992 avevo 29 anni, avevo fatto coming out in famiglia, con amici e conoscenti già da un paio di lustri, ero abbastanza visibile sul lavoro – quanto meno non negavo alcunché – e avevo un rapporto sentimentale che consideravo solido, con un compagno con cui convivevo da qualche anno. Eppure, non avevo dimenticato – come avrei potuto? – gli anni della mia infanzia e della mia prima adolescenza di ragazzino omosessuale: quella sensazione di oppressione e di solitudine che non mi lasciava mai, quella sottile e costante paura che il mio sergreto fosse scoperto, quell’inquietudine dovuta al non saper identificare con chiarezza i miei desideri e quella tensione erotica che cresceva velocemente, forse addirittura più velocemente della mia stessa età anagrafica. Molto precocemente, il sesso lo avevo scoperto grazie a un vicino di casa più grande: ma non era altro che un esercizio meccanico, un uso senz’altro consapevole dei nostri corpi – quanti fumetti e giornali pornografici ci capitavano in mano in quegli anni, in cui lo stesso mondo degli adulti stava cercando di venire a patti con la liberazione delle proprie fantasie sessuali! -, che, però, non legittimava, anzi atrofizzava, la mia improvvida voglia di provare sentimenti come tutti i miei coetanei, non solo sensi di colpa. Era pur vero che in quella obbligata segretezza, in quella condizione equivalente per molti al peccato, se non alla malattia, in quella libera precipitazione verso gli inferi, io presto cominciai a sentire maturare in me col passare del tempo una incipiente forza interiore, un iniziale barlume di desiderio di emancipazione. In qualche modo, di questo devo essere grato alla politica, che in quegli anni permeava la nostra quotidianità e che – malgrado alcune rigidità ideologiche – ci permetteva di guardare al mondo esterno come a qualcosa di imperfetto e di considerare i giudizi come semplici pregiudizi contro cui combattere.
Con questo non sto certo affermando che i miei compagni del tempo considerassero l’omosessualità come socialmente e politicamente accettabile. Tutt’altro. Ci sarebbero voluti ancora molti anni. Su tutti ho un ricordo. A metà anni Settanta, a Sesto San Giovanni, nel quartiere dove abitavo, c’era un personaggio che – forse suo malgrado – era oggetto di morbosa curiosità e, non di rado, crudeli attenzioni, soprattutto da parte di noi ragazzini. Si chiamava Michelle ed era un travestito. Non ne ricordo i tratti somatici precisi, ma solo un’idea di insieme: una figura femminile dall’aspetto deciso, oserei dire fiero, quasi di sfida nei confronti del mondo circostante. Ne parlo al maschile solo per adeguarmi al contesto del tempo. Allora a nessuno sarebbe venuto naturale parlare di un travestito utilizzando il femminile, non vi era alcuna coscienza del concetto di identità trans: un travestito era un uomo vestito da donna.Quando mi capitava di incrociarlo per strada, ero combattuto tra una non del tutto cosciente ammirazione e l’immotivato timore di doverlo considerare un modello di riferimento possibile per il mio futuro di adulto. Parliamo di anni in cui non erano molte le figure pubbliche di omosessuale e, nella quasi totalità dei casi, esse erano così lontane dalla medietà umana da sembrare pure eccezioni alla norma: più utili a confermarla, la Norma, che a metterla in crisi. Michelle era un personaggio misterioso, il suo camminare per le vie del quartiere creava reazioni tra il divertimento e lo sdegno. Parliamo di tempi in cui il fatto che un uomo vestisse così temerariamente – e così bene! – abiti femminili non poteva che sembrare un intollerabile atto di provocazione. Tanto esplicito da lasciare annichiliti. Eppure quello del travestitismo, per quanto un novità nelle sue manifestazioni nella quotidianità e alla luce del sole – non come il travestitismo a porte chiuse, praticato da tempo immemore – attirava già da qualche anno l’attenzione di certa stampa: testate come Il Borghese e Lo Specchio ci andavano a nozze, pubblicando frequentemente pruriginosi reportage sulle retate nei locali particolari di Torino o di Roma. La grande fotografa Lisetta Carmi sin dal 1965 aveva scattato molti rullini con le Bocca di Rosa di via del Campo, uno dei primi ghetti omosessuali a Genova, uscendo con un volume nel 1972. Non mancavano le testimonianze dirette degli interessati: la casa editrice M.E.B. di Torino, nel 1970, aveva dato alle stampe il libro autobiografico Io, un travestito di Roberto Franciolini, che negli anni a seguire sarebbe diventato l’attivista Roberta Franciolini, figura di riferimento del FUORI! torinese e tra le fondatrici e le più strenue attiviste del M.I.T., il Movimento italiano transessuali, nel 1980. Ma noi, ragazzini abituati a giocare in strada, che ne sapevamo?

Credo io fossi in prima o seconda media, uno dei più piccoli della proletaria combriccola del quartiere. Piccole azioni calcistiche interrotte dal passaggio di una macchina nella via. Un palleggio scomposto e il pallone alza la sua traiettoria e finisce a colpire una persona che passa sul marciapiede opposto. Era Michelle. Attimi di silenzio. La sensazione di aver alterato un equilibrio. Poi il mondo si rianima, Michelle recupera la palla, la lancia verso l’alto e quando nella discesa impatta contro il suo piede destro acquista la velocità di un bolide e finisce oltre la recinzione di un campetto privato. Noi rimaniamo per un po’ come imbambolati, mentre l’improvvisato goleador si è già voltato e allungava il passo. Non ricordo chi fu ad urlare “frocio!”. Ricordo però che tutti, anche io, cominciammo a sghignazzare alimentando l’un con l’altro la nostra ilarità. Ho ripensato a questo episodio nel gennaio del 2022, quando abbiamo pubblicato il quattordicesimo episodio del podcast Le Radici dell’Orgoglio, intitolato Chiamami con il mio nome: la battaglia per la legge 164 (1982). Era un monografico sulla nascita in Italia del M.I.T, il Movimento Italiano Transessuali e sulla successiva strenua battaglia per l’ottenimento della riattribuzione anagrafica per le persone transgender. Nel prologo dell’episodio scrivevo:
La storia che stiamo raccontando da settimane con questo podcast è quella di una comunità, che, dopo aver sperimentato l’oppressione, la violenza, la sofferenza e il disagio per la propria condizione indotti da una società stolidamente eteronormata, ha compreso e affermato il valore di sé e ha saputo alzare la testa e combattere per rivendicare la propria identità e i propri diritti negati. L’attuale comunità LGBTQI+ è il risultato del coraggio e dell’amore per la libertà di chi ha deciso di uscire allo scoperto, di venire fuori dalle zone d’ombra e di buio in cui era stato costretto a vivere. Questa consapevolezza ci ha sempre accompagnato nella raccolta del materiale e nella scrittura delle Radici dell’Orgoglio. Ma l’episodio di oggi ci ha regalato – se possibile – un senso di orgoglio ancora più forte e determinato, perché parla di persone che, per quanto vessate, derise, disprezzate, anziché nascondersi o adattarsi, hanno scelto di liberare fieramente il proprio corpo dalla sudditanza di un genere in cui non si riconoscevano. Le persone transessuali sono state giocoforza alfieri della visibilità. Una visibilità che ha avuto un caro prezzo in termini di violenza e che, quando faceva capolino sui mezzi d’informazione, era solo per dare sfogo a pruderie e senso del grottesco.
Credo che la passione spesa nel confezionare quell’episodio sia stato un modo per chiedere, a distanza di così tanti anni, scusa a Michelle – e con lei a tutte le Michelle di quegli anni duri e cattivi – per quella sciocca risata e, soprattutto per quel “frocio” – che oggi so essere del tutto fuoriluogo – che avevo condiviso con i miei compagni di allora. Oggi mi è chiaro chi tra noi fosse davvero libero. Lei, malgrado lo stigma e la discriminazione, aveva fatto una scelta coerente con ciò che sapeva di essere. Io, ridendo, mi stavo ancora condannando alla menzogna e alla negazione.
Il podcast Le Radici dell’Orgoglio e tutte le iniziative che recuperano la nostra storia e la nostra memoria vogliono pagare un tributo a tutti coloro che non si sono piegati alla menzogna e alla negazione e che hanno scelto di impegnarsi in una lotta di liberazione ed emancipazione non solo per se stessi, ma per tutti coloro che mai ne avrebbero avuto il coraggio. L’orgoglio che oggi proviamo lo dobbiamo a loro.