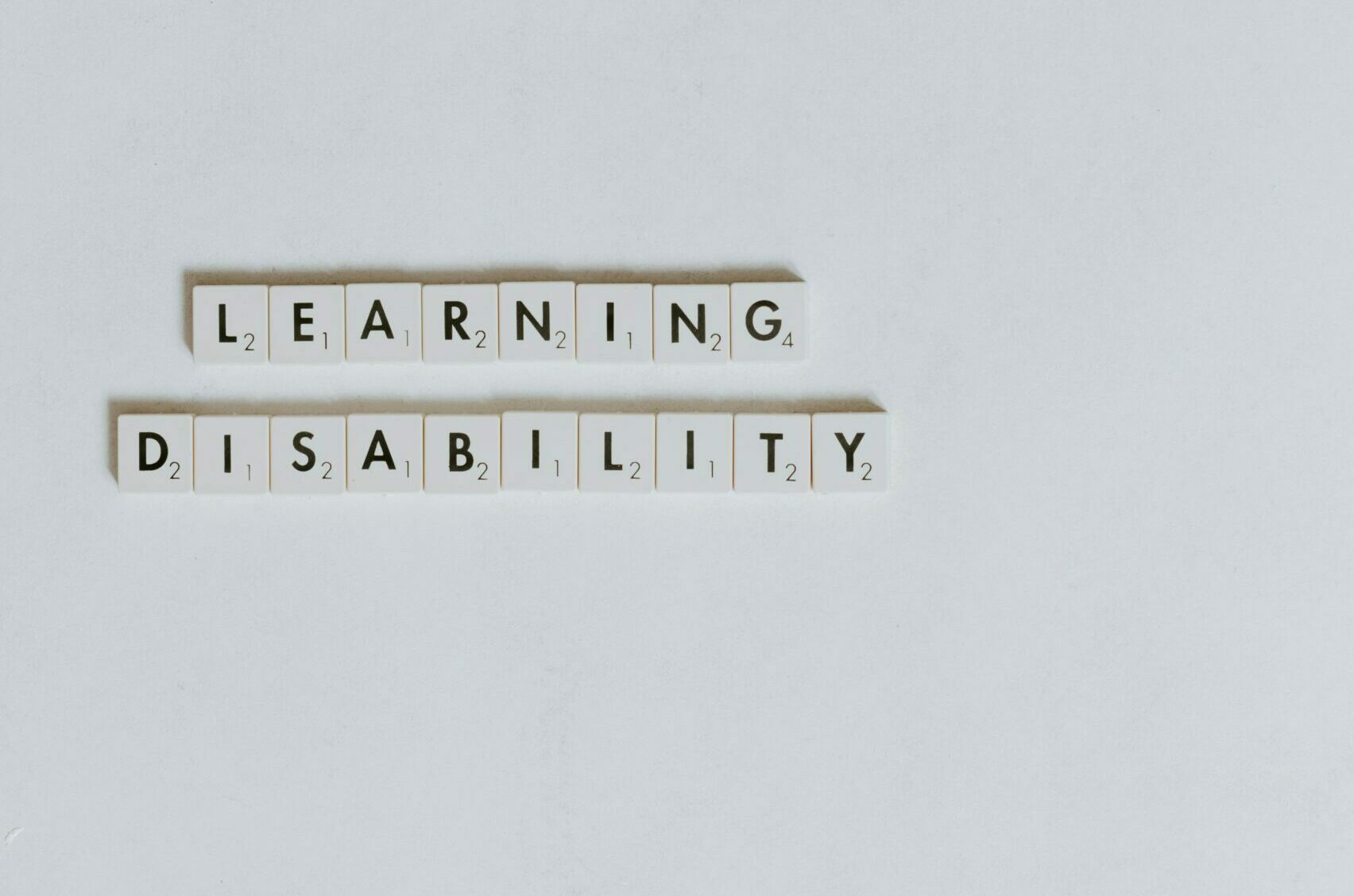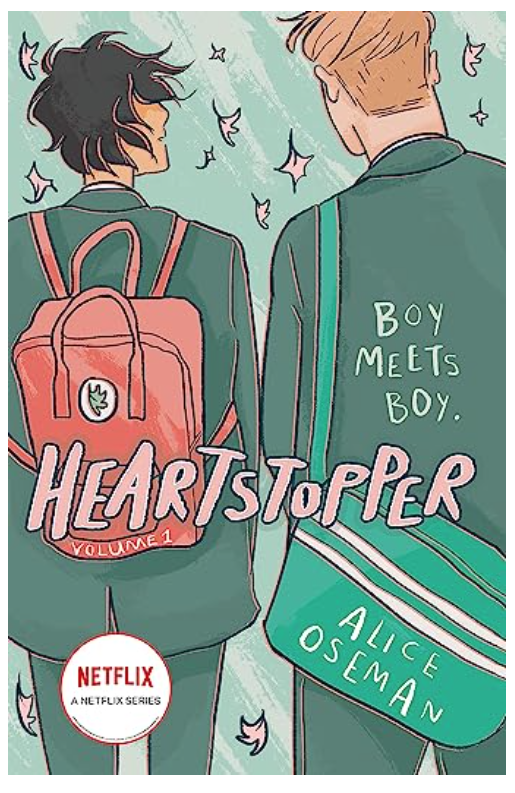“Napoli è una città che trovo vibrante, creativa, dove si lotta per vivere, ma splendida.” Così Peter Brook descrive questo agglomerato misterico, sacramente profano, inclusivo e impenetrabile al tempo stesso.

Neapolis – la città nuova o la città che si rinnova? – affonda le sue memorie nel ventre della sirena Partenope e vive pericolosamente all’ombra del Vesuvio. In bilico fra i generi, fra i mondi, sulla linea sottile fra passato e futuro, eppure eternamente presente. Come persino gli eventi del Festival di Sanremo ci suggeriscono. Vicoli in cui perdersi e piazze in cui ritrovarsi, combattere, o almeno tentare, gridando per la giustizia, più spesso per la vita, come tanti Masaniello. Ma Napoli è anche un reticolo di persone – oltreché di vie – che, attraverso le epoche, hanno cantato storie di sopravvivenza e di riscatto, di affermazione – persino identitaria – e di libertà, con tante voci ora inquietanti e melodiose, ora graffianti e terribili. Enzo Moscato era una di queste voci.

Nato nei Quartieri spagnoli e cresciuto a Piedigrotta, divenne parte fondante di una nuova drammaturgia della città, insieme all’amico Annibale Ruccello e a pochi altri. Il post-Eduardo: decadenza contemporanea a confronto di un teatro di ricostruzione, ma anche riflessione amara e crudele, indagine antropologica delle trasformazioni degli anni Settanta e Ottanta – fino ad oggi – sui luoghi e sui corpi.

Scannasurice (1982) è spettacolo emblematico di questa compenetrazione fra città e abitante: Napoli è la protagonista. La Napoli dei quartieri spagnoli, inaccessibili, pericolosi e affascinanti come una Qasba; la Napoli dei femminielli, anime androgine e misteriose, figlie degli antichi culti pagani, dei riti di purificazione, ma anche dei cantori barocchi, castrati loro malgrado e spesso sfortunati prostituti; la Napoli della distruzione e della speranza, del gioco e della scaramanzia, dei fantasmi e dei topi, metafora, questi ultimi, degli stessi abitanti ridotti in estrema condizione di vita persino dalla natura, eppure sempre vitali, ostinatamente in cerca di cibo e di sopravvivenza. La Napoli distrutta dal terremoto ed eternamente da ricostruire.
Un luogo, un tempo e un suono, “un système où tout se tient”, contraddittori e armonici, proprio come il popolo che la vive: questo è alla radice del suo teatro in cui si intersecano spazi urbani e narrazioni, melodie e corpi. Un teatro che racchiude Napoli e la attraversa nei secoli, nelle memorie e nelle accezioni più dolorose e più tenere. Dal citato Scannasurice (1982), presentato alla Biennale di Venezia, con il suo gruppo teatrale di studenti fino al caleidoscopio di suoni, musiche e figure di Occhi gettati che chiuse – in via definitiva – la rassegna romana del Garofano verde, scenari di teatro omosessuale nel 2017, passando per Trianon (1983) e Bordello di mare con città (1986 e 2016), Ragazze sole con qualche esperienza (1985), Piece Noire (1987), Rasoi (1991 che diventerà un film per opera di Mario Martone), Luparella (1997), Sull’ordine e il disordine dell’ex macello pubblico (2001), dedicato alla rivoluzione napoletana del 1799, e lo splendido Lacarmèn (2015), trascrizione-reinvenzione dell’opera di Bizet. Ma tante altre sono le sperimentazioni di questo autore-attore-regista dalla preziosa personalità.
Un lungo percorso, a confronto dell’amico Annibale Ruccello prematuramente scomparso, che ha accompagnato anche la trasformazione di quegli stessi luoghi, di quella stessa popolazione per mezzo di una drammaturgia baroccheggiante – come l’architettura partenopea – in eterno ritorno, in costante evoluzione elicoidale.

La sua scrittura è infatti transustanziazione dolorosa, tragica e ineluttabile della stessa Napoli – atto mistico come il sangue di San Gennaro – da cui prendono avvio a loro volta le vicende, i personaggi, i suoni, le lingue e verso cui ritornano in un ciclo vitale eterno, mitico e contemporaneo al tempo stesso.
“Attraverso il teatro Napoli esprime spudoratamente il suo stato di capitale del Sud del mondo.” scrive Mario Martone. Moscato ha espresso Napoli con la stessa spudoratezza, narrando un mondo parallelo di emarginati, prostitute e omosessuali, metafora di una condizione esistenziale sospesa tra il maschile e il femminile e allo stesso tempo tra l’Oriente e l’Occidente, cui ha affiancato livelli stilistici diversi tra loro, con mescolanza di lingue e dialetti, come partiture musicali.
A distanza di un mese dalla sua morte, restano le sue parole, i suoi personaggi, le sue storie che si fondono e si confondono ai vicoli, ai profumi, alle luci radenti sui palazzi facendosi Storia e Memoria, eterne e fuori dal tempo. Resta il suo teatro che non possiamo e non dobbiamo dimenticare.