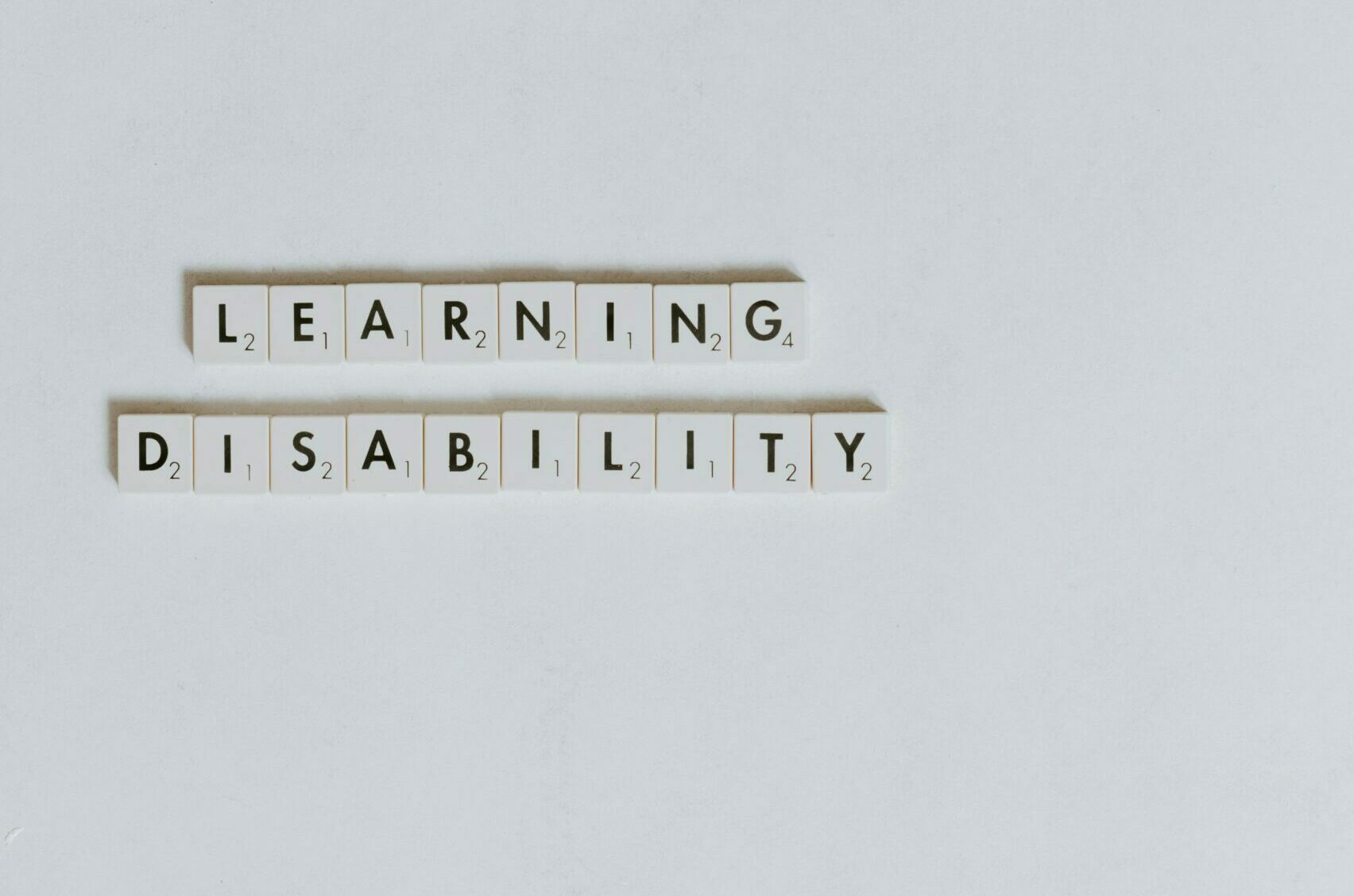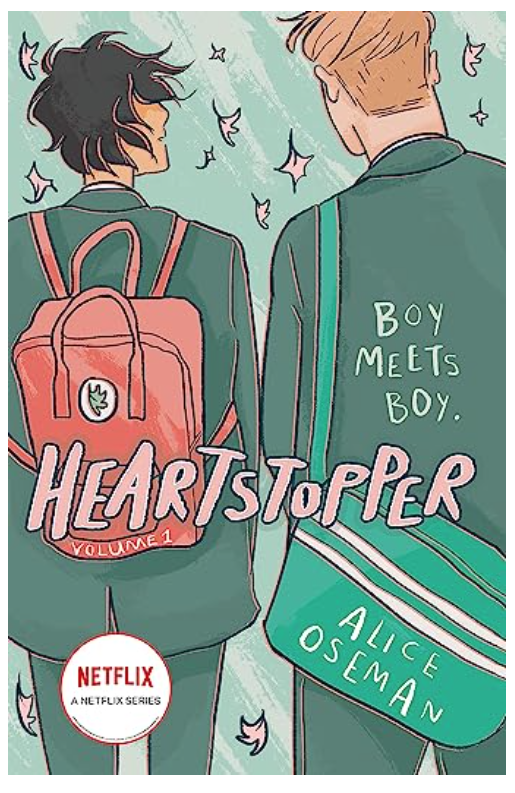Una domenica mattina ho sentito mia zia dire la parola “queer”. Stava commentando qualche servizio in TV o un telefilm, non ricordo, so che in quel momento la mia testa ha fuso in un cortocircuito come quando si sovraccaricano le schede dei computer.
È indubbio che negli ultimi anni le identità subalterne abbiano delineato, definito, ricercato, conquistato il proprio essere, i propri confini, i possibili spazi. C’è stata un’evoluzione che ha coinvolto tecnologie, strumenti e luoghi digitali che dai collettivi di studi di genere negli Stati Uniti, è passata per una piazza o conferenza italiana e alla fine si è infilata fin dentro un servizio della TV generalista italiana. Mia zia che parla di “queer” e la mia mente fa una capriola.
Viviamo tempi in cui il discorso identitario da tempo non ristagna più nei luoghi reali dei circoli LGBTQIA+, ma valica le mura, le tessere, gli spazi dedicati, i blog tematici, le conferenze, i solipsismi, i monologhi teatrali o le arringhe dai palchi dei Pride (diciamo dal World Pride del 2000? Diciamolo).

Nuove identità come un processo di mitosi hanno conquistato prima le nostre menti, i nostri discorsi, i nostri spazi e poi -deflagrando- i nostri linguaggi.
Nuove identità nascevano nelle sale fumose e polverose dei circoli di sezione, e ora incubatori sono soprattutto i luoghi virtuali, tra i forum internet, profili social, dirette Twitch (possiamo dire che la comunità asessuale e aromantica è nata prima nei luoghi digitali e poi reali? E diciamo anche questa).
Il pensiero critico ha costruito e decostruito incessantemente parole, discorsi, obiettivi, istanze, divincolandosi dalle pagine dei filosofi post-strutturalisti e andando ad annidarsi in un discorso politico, una discussione, un post Instagram, un articolo di rivista, sotto un selfie, a un commento nel salotto TV, fino nel tinello di mia zia.
Se virali erano i nostri corpi alla fine degli anni Sessanta, virale diventa il nostro linguaggio che ci definisce, straccia epistemologie e impone nuove tassonomie, mappe con cui orientarsi nei percorsi di autodeterminazione, in quel + del nostro acronimo.
Ma quanto sarebbe sciocco pensare che questa evoluzione riguardi soltanto noi.
“Dobbiamo garantire alle donne la libertà di essere madri”, ha tuonato col pugno alzato, mesi fa la ministra per le Pari Opportunità Eugenia Roccella.
Durante la discussione del DDL Zan nel luglio del 2020, L’On. Matteo Salvini dichiarò in aula: “Presentiamo un ddl contro l’eterofobia”.
Cerchiamo il casus belli più celebre nell’ottobre 2019 a Piazza San Giovanni a Roma, qui la futura Presidente del Consiglio pronuncerà un celebre discorso che diventerà fin troppo conosciuto e tradotto: “Vogliono farci diventare genitore 1 e genitore 2, genere LGBT, cittadini X! Dei codici! Ma noi non siamo dei codici, siamo persone, e difenderemo la nostra identità!”.

Nel racconto della libertà di essere madre rispetto a una surreale imposizione di aborto, nel racconto del difendere valori di identità minacciate benché maggioritarie e oppressive, in quello della ridicola invenzione di una “cancel culture”, di una “teoria gender”, c’è una morfologia che attinge a piene mani dalle nostre storie di resistenza e liberazione, ruba le nostre parole, travisa i nostri termini, in un’appropriazione che confonde e lascia solo quel senso di rivalsa, di senso di giustizia, benché la giustizia sia di casa altrove.
Così al femminicidio si contrappone una storia uguale e contraria che possa annullarne la propulsione, quella del “maschicidio”, con buona pace dei dati che parlano di un rapporto 1 a 50.
Ai diritti di tutela della comunità transgender, si avanza il racconto dello spazio femminile minacciato, abusato, violato.
A quello della GPA, si racconta di ragazze disperate e sfruttate.
La retorica delle destre negli ultimi anni ha cambiato vestito, appropriandosi di quello dei resistenti, dei reietti, degli abusati, mostrandosi così più accomodanti e moderati.
Il nuovo racconto a carta carbone, benché strappato e rattoppato alla bene e meglio, ha convinto l’inconvincibile, ha coperto il nero e i fasci littori, ha accecato sulla sua presentabilità, fino a porre un Presidente del Senato che di secondo nome fa Benito (nome e titolo ad honorem).
Perché quella continenza, quella decenza, tale non è se gli strumenti al loro servizio restano gli stessi: silenzio, rimozione, violenza, prevaricazione.
Nella costruzione delle nuove identità, sta emergendo dall’invisibilità anche quella del nuovo fascista, sia a livello morfologico contenutistico, che semiotico iconografico.
Nel suo ultimo saggio “Dysphoria Mundi”, Paul B. Preciado parla ampiamente della parabola mimetica che dalla richiesta di “legittimo spazio vitale” di Adolf Hitler, arriva all’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Quel giorno i nuovi fascisti erano in streaming sui nostri telefonini: attuavano un colpo di stato e performavano, distruggevano mettendosi in posa, mischiavano il vilipendio coi selfie e le GIF.
La polizia faceva foto di gruppo in un Campidoglio diventato un parco Disney occupato.
I riferimenti storici delle bandiere confederate erano legati a doppio nodo con felpe di brand alla moda: “fashion” e “fascismo” facevano assonanza.
Niente più riferimenti militari, nessuna divisa o omologazione gerarchica, spariscono sempre più i riferimenti religiosi e ai crocifissi e alle bibbie brandite minacciosamente, si sostituiscono smartphone e fotocamere.
A Gesù si preferisce Thor: i capelli sono simili, il corpo più nerboruto, virile e tatuato, diventandone la versione super-sayan norrena.
Si moltiplicano le bandiere di orgoglio eterosessuale, orgoglio bianco, “All lives metters”, “White Lives metters”, “Non tutti gli uomini”, “Etero Pride”.
I corpi nudi erano gli strumenti di battaglia nelle strade durante le nostre manifestazioni, dalle tette delle compagne femministe a quelle delle compagne transgender: se volete fare la guerra ai nostri corpi, eccoli, sono pronti, vi accecheremo coi nostri capezzoli.
Ora i corpi nudi sono i loro: palestrati, sexy, calzano cappelli di pelliccia con colorati make-up, come nei migliori spettacoli drag.
Violenti Incel parlano di pillole rosse e pillole blu, sovvertendo un film di due registe transgender che con la fantascienza di Matrix hanno raccontato come disinnescare la cultura sistemica del binarismo di genere.
A noi, un po’ meno doloroso, ci hanno rubato Cristina D’Avena.
Nei nuovi fascisti c’è tutto, come fosse il frutto di un algoritmo di Netflix: nostalgia, tecnologia, cultura pop, religioni più avvincenti, grafiche instagrammabili, cibernetica, vecchi libri fantasy, ma soprattutto senso di vittimismo e ingiustizia.
E poi ancora slogan buoni per i tag sui social, in uno scandire di pay-off e claim che dal pubblicitario smarginano nella propaganda: la mascherina è un bavaglio, la quarantena una prigionia, il vaccino è uno strumento di controllo.
Si ribaltano i ruoli, si usurpano gli archetipi, in un furto di codici che non sappiamo ancora decodificare, preservare, contrastare.
Ricordo quel remix di “Io sono Giorgia” suonato anche nei club LGBTQIA+ in una totale confusione semantica di chi rideva allo sberleffo e chi spettatore e spettatrice sentiva vicini e comprensibili quei toni.
Non so in cosa ci trasformeremo noi, non ho la più pallida idea delle sembianze che avranno i nostri nuovi nemici, so che la prospettiva storica e la contezza di cosa è violenza e oppressione, mi salverà dall’ennesimo meme, dall’ennesimo slogan, dall’ennesimo diritto calpestato.