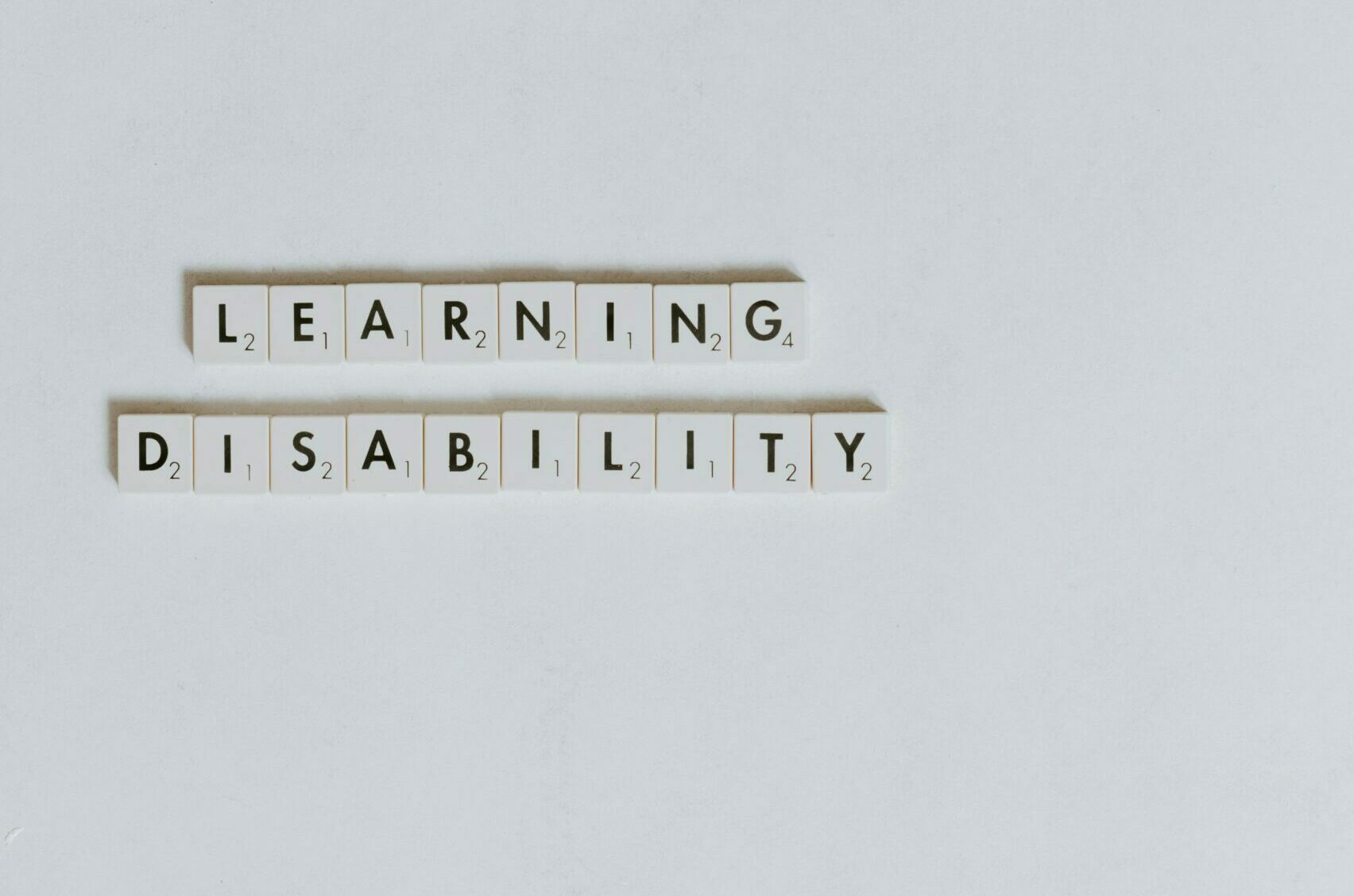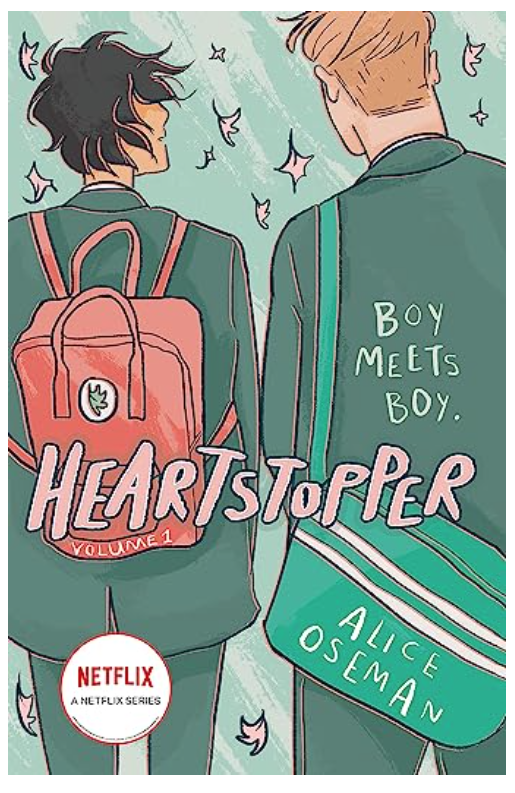Com’era
“Perché non me l’hai detto?”. Mi rivolge la domanda senza tono di accusa nella voce. Percepisco un filo di sorpresa mista a genuina incomprensione, tipica di un genitore che per la prima volta vede la persona oltre la figlia. Io e lei stiamo riattaccando i pezzi della nostra relazione un po’ ammaccata. Versiamo oro tra le crepe, come nella antica tradizione giapponese. Rimettiamo insieme i cocci rotti e costruiamo qualcosa di nuovo e di prezioso. Mi guarda in attesa di risposta e mi chiedo se davvero non sa cosa stia per dirle o se lo ha dimenticato. Se ha rimosso tutti i piccoli ma puntualissimi ed immancabili commenti alle notizie in tv ogni qualvolta passavano qualcosa di gay. I commenti potevano essere di varia natura ma rientravano sempre in 3 ben distinte categorie: la pietà, lo schifo e la vergogna. Generalmente ne “La pietà” rientravano tutti i commenti che si distinguevano per una sorta di empatia per il prossimo “chissà come fanno a vivere così poverini”, “pensa alla madre di uno così? Non puoi vivere in quella maniera…senza una famiglia, senza fare i figli… poverini” e altre variazioni sui generis. Sempre e comunque poverini. Lo schifo.
Ora potrei definirlo una manifestazione della paura etero-patriarcale di scoprire che le basi dell’egemonia eterosessuale sono labili e culturalmente definite. Non di certo naturali. Fragili al punto da dover continuamente rinforzare il concetto di eterosessualità e di compatibilità tra uomo e donna in ogni aspetto della vita quotidiana; imponendo sistematicamente il rifiuto di qualsiasi deviazione dal binarismo. Si esige l’uomo duro, aggressivo, sempre deciso e nel contempo si pretende una forma femminile canonica prefabbricata e prefritta. Mista santa, mista mamma e mista tr*ia. La conseguenza è che per molti la sfida più grande della vita diventa essere davvero se stessi o almeno provare a conoscersi, spogliandosi il più possibile dalle imposizioni sociali e capitaliste che ci stanno particolarmente strette.
All’epoca, a 13 anni, guardando il TG4 con i miei genitori, non sapevo che l’espressione di Emilio Fede riflettesse l’etero-patriarcato impaurito. Mi sembrava solo disgusto per le bandiere arcobaleno in piazza e le persone seminude che ci ballavano attorno. I giornalisti con il microfono si avvicinavano ai manifestanti, sempre meglio se mezzi svestiti o se uomini vestiti in abiti femminili: “Perché oggi sei qui?”, “Perchè sono orgoglioso di chi sono e voglio celebrarlo”. E taaac. Scattavano i commenti de La Vergogna : “Ma come si fa ad andare in giro conciati così? Ma non si vergogna? Ha pure il coraggio di parlare davanti a delle telecamere!”, il tutto accompagnato da grandi sospiri di delusione.
A volte però niente di tutto questo succedeva. A volte semplicemente si cambiava canale, magari con un leggero moto di fastidio. Moscerini da scacciare. Ricordo che mi rattristava molto di più il cambio veloce del canale. Non voler vedere quei colori e quelle persone era, per me, peggio di tutto il loro schifo.
Come è diventato
Quando poi è arrivato il mio momento di scendere in piazza non ho pensato nemmeno per un momento ai commenti con cui sono cresciuta. I miei preferiti erano “i primi” Pride. Comunità e associazioni che si organizzavano per poter portare la manifestazione in città per la prima volta. L’emozione collettiva sempre palpabile. La voglia di urlare per farsi sentire mista alla voglia di urlare contro tutto quello che. L’obiettivo per me era anche quello di dare fastidio alla pace della cittadina di turno. Disturbare la quiete era una gioia. I percorsi delle passeggiate della domenica interrotti dalle transenne per farci passare. Gli automobilisti scocciati di dover assistere forzatamente al passaggio del corteo. I passanti costretti a fermarsi o a camminare ai lati della strada. La curiosità delle commesse sulla soglia delle vetrine dei negozi, ferme a osservarci come civette. Il sorriso della vecchietta sul balcone che in quel momento ti vede davvero e ti lascia un briciolo di speranza.
La sera tornavo a casa e fantasticavo immaginandomi il pride nelle strade del paesino da 5mila abitanti in cui vivevo. Vedevo nella mia testa la fiumana di persone passare dall’oratorio alla piazza della chiesa e poi davanti a casa mia. Le espressioni di disgusto dentro casa ed io che allora uscivo con sprezzo, con un outfit sfavillante che manco sailor moon, pronta ad unirmi alla folla a ritmo di Crazy In Love.
Crescendo poi le fantasie sono scemate e sono aumentate le domande. La mia unicità nel mare di gente saltellante ha cominciato a farmi storcere il naso. Possibile che ci sia qui solo io? Dove sono gli altr3? Ce ne sono altr3? Non ho mai trovato rappresentanza non bianca in queste manifestazioni. Come del resto non ne trovavo fuori in altri contesti. I cortei diventarono l’ennesimo spazio in cui poter rivedere solo una parte di me e mai me stessa completamente. A tratti mi sono sentita sola.
Pride oggi, per me.
Nel corsi dei Pride Month degli ultimi anni ho notato una predisposizione all’ascolto dell’altrə, almeno sui social. Personalità appartenenti a categorie discriminate vengono interpellate su cosa significhi vivere nelle loro condizioni. È l’inizio di una conversazione che può essere davvero interessante, purché non sia performativa e utile solo in prospettiva del Pride Month.
Ad oggi posso dire che l’intersezionalità all’interno della comunità LGBTQAI+ è un concetto delicato, ancora non pienamente considerato. A mio parere, il primo ostacolo è la “discriminazione nella discriminazione”, ossia il fatto che anche nella comunità ci siano stereotipi e pregiudizi che portano alla marginalizzazione di determinate categorie come persone razzializzate, disabili, non binary, agender.
La comunità LGBTQAI+, purtroppo e per fortuna, non è immune al condizionamento sociale e quindi è anch’essa dominata da una supremazia bianca, patriarcale e abilista. Trovo però che almeno adesso ne stia lentamente prendendo coscienza, grazie al fatto che le minoranze sono più visibili, alzano la voce e comunicano le criticità di questi eventi. Questo potrebbe essere un primo passo risolutivo: il dialogo.Mantenere il dialogo è essenziale per ricordare che la ricerca di pari diritti non è ancora conclusa, e se non stiamo difendendo gli interessi di tutti, non stiamo agendo correttamente. È necessario ricordarlo soprattutto a chi ha più privilegi. Se non stiamo alzando la voce per la violenza che subiscono le persone trans, per il trattamento riservato alle persone nei CPR, per il diritto alla salute mentale dei più giovani, per un’educazione all’Altro che parta dalle scuole, per il diritto alla famiglia,alla cittadinanza, ad una vita dignitosa, allora cosa stiamo facendo?
Grande dibattito recente è quello delle sponsorship. La partecipazione delle aziende al Pride è ormai accettata e inizialmente sembrava essere un gran passo avanti, un riconoscimento sociale utile a diffondere un’immagine positiva del Pride. Tuttavia, con l’aumento delle compagnie che supportano pubblicamente il Pride, sono emerse due problematiche che temo vadano a distorcere alcune colonne portanti del significato dell’evento. In primis, per rendere più digeribile la narrazione del Pride, è stato diffuso un messaggio troppo incentrato sul lato sentimentale e romantico. Il motto “love is love”, per quanto orecchiabile, non è inclusivo e soprattutto elimina il concetto della libertà di essere. Prima ancora di celebrare l’amore per altrə, la rivoluzione del Pride valorizza l’amore per sé stessə e la libertà di vivere la propria vita senza paura e con orgoglio. Una delle conseguenze può ovviamente essere anche la libertà di vivere le proprie relazioni come si preferisce, ma non è mai stato il punto focale del Pride e non è accettabile che lo diventi solo per andare incontro al gusto sociale eteronormato. In secondo luogo, il supporto delle aziende a volte è falso ed ipocrita, poiché mirato esclusivamente ad allargare il proprio bacino di clienti. Dietro a questo rainbow-washing non sempre esiste però alcun supporto economico concreto che sostenga realtà LGBTQAI+ e i loro bisogni. Altro non sono che mosse di marketing fini a sé stesse. Esattamente ciò di cui non abbiamo bisogno, quando si tratta di alleatə. Per continuare a far sentire la nostra voce c’è bisogno di trasparenza da parte delle aziende e più controllo da parte di chi consuma. In definitiva, sarebbe giusto non accontentarsi di qualche arcobaleno in più sui nostrə prodotti preferiti, ma assicurarci, per quanto possibile, del sincero coinvolgimento da parte dei brand.
Pride domani, spero
Uno degli ultimi Pride a cui sono stata è stato quello vissuto con mia sorella minore. Quando si hanno 13 anni di differenza a volte è più complicato trovarsi, sia praticamente che mentalmente. Perciò ero entusiasta di viverlo con lei. Grata di vederla sicura e a suo agio nel ribadire qualcosa che per la sua generazione sembra essere quasi scontato. Rifletto sulla bellezza della nostra presenza assieme in quella piazza, nonostante tutto, anni di distanza. Rifletto sul fatto che quello pareva complicato, ora sembra a tratti quasi ovvio. Lancio un monito a me stessa. Si preannuncia un periodo capace di metterci a dura prova, perché ciò che abbiamo davanti è un vento contrario che va direzione opposta. Peggio. In una direzione pericolosa. Nel quotidiano, poco a poco, tra lo sdegno dei più (sono veramente più?) qualcosa rischia di venirci sottratto semplicemente perché possibile. Perché ai più (speriamo non siano davvero più) non importa di noi.
La storia ci ricorda in mille modi quanto è semplice concentrarsi su ciò che si ha individualmente piuttosto che pensare alla collettività. La paura, il privilegio. Il pensiero che non capiterà mai a noi. Tutte cose che ci distolgono da una verità banale ma importante: il Pride è lotta e la lotta non è ancora finita.