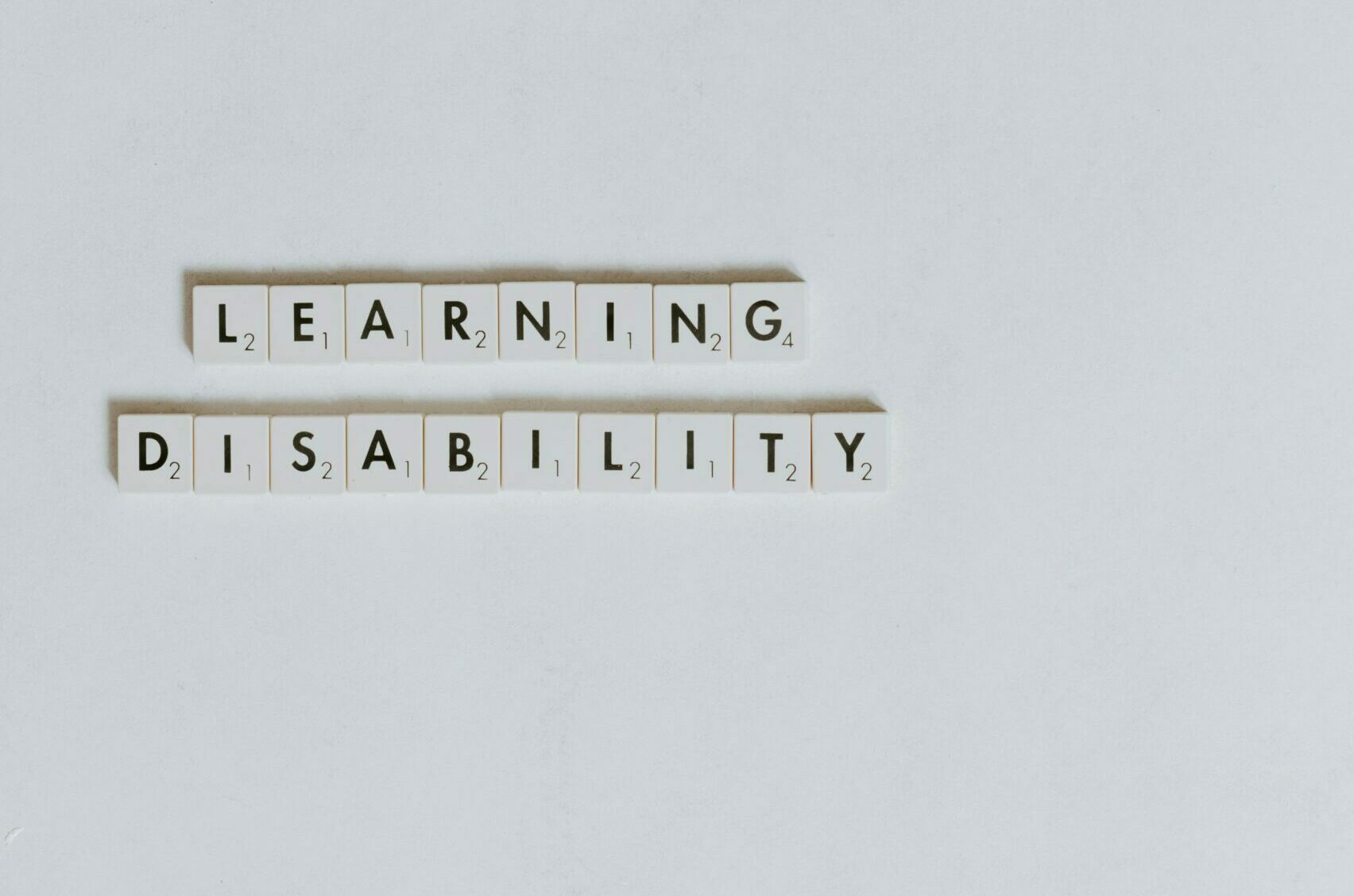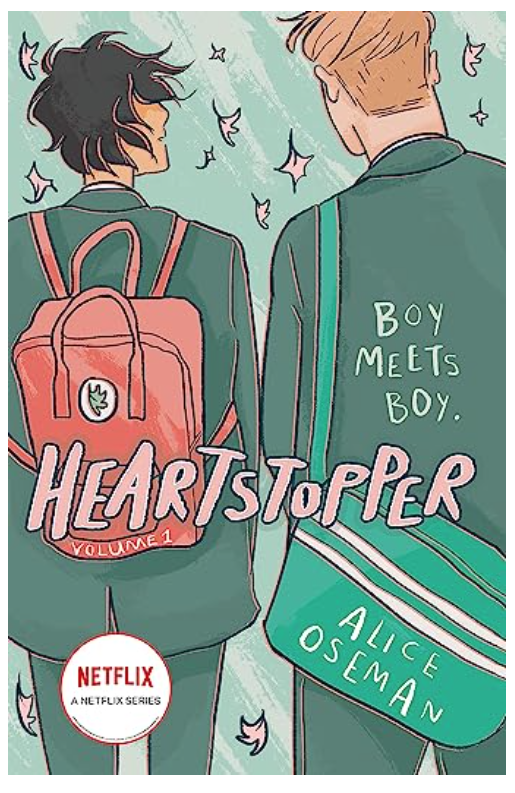Nel 2024 parleremo ancora di rainbowashing in occasione del Pride Month? Secondo me sì. Fortunatamente, forse proprio grazie alla Gen-Z, le tematiche legate all’etica e alla trasparenza delle pratiche commerciali stanno tornando in alto nella lista delle priorità di aziende e istituzioni. Noi, Millennials, restiamo un po’ sconfitti e sconsolati ai posti di partenza della discussione, ma non possiamo risolvere tutto con un “largo ai giovani”, ve ne prego.
Nel 2024 parleremo ancora di rainbowashing in occasione del Pride Month? Secondo me sì. Fortunatamente, forse proprio grazie alla Gen-Z, le tematiche legate all’etica e alla trasparenza delle pratiche commerciali stanno tornando in alto nella lista delle priorità di aziende e istituzioni. Noi, Millennials, restiamo un po’ sconfitti e sconsolati ai posti di partenza della discussione, ma non possiamo risolvere tutto con un “largo ai giovani”, ve ne prego.
Nel caso non foste mai inciampati nel termine “rainbowashing”, facciamo un ripasso di base, molto essenziale ma che ci permette di capire di cosa stiamo parlando e di avere una bussola quando ci troveremo di fronte alla prossima campagna marketing con arcobaleni e frasi come “Love is love”.
Per “rainbowashing” intendiamo attività commerciali, di marketing o di comunicazione che, ai fini di vendita, posizionamento e reputazione, associano un prodotto, un servizio o un’azienda/istituzione alle tematiche dell’inclusione delle persone LGBTQIA+ senza però avere alcun tipo di concretezza e sostanza, né esternamente (appoggiando, ad esempio, un’associazione LGBTQIA+) né internamente (con politiche interne per i propri dipendenti).
Prima di passare a come riconoscere un’attività di effettivo sostegno alla causa queer e un’attività meramente di rainbowashing, facciamo una brevissima parentesi d’inizio: è giusto o meno che i nostri temi, le nostre battaglie e i nostri simboli entrino nelle dinamiche del marketing?
Potremmo riempire pagine su questo argomento, e ci sono persone che sono sicuramente molto più titolate di me per parlarne, ma il mio punto di vista, che è fallace, correggibile, migliorabile, mutabile e così via, è che nella società capitalistica in cui viviamo preferisco che questi temi entrino nelle sensibilità mainstream anche grazie al marketing e che sfruttino proprio questi volani di visibilità e rappresentanza per raggiungere più persone possibili. Mi spiego meglio con un esempio: Coop Italia, la catena di supermercati per intenderci, conta più di 6 milioni di soci. Soci, non clienti. I clienti saranno esponenzialmente di più. Ecco, se Coop Italia durante il mese del Pride fa una campagna sulle tematiche dell’inclusione della diversità e sostiene progetti per la comunità LGBTQIA+, ne parla sui suoi canali e nei suoi punti vendita raggiungendo 6 milioni di soci e clienti, persone che probabilmente non avrebbero mai avuto nessun tipo di stimolo sul tema altrimenti. Pensiamo che questo cambierà il mondo? No, non di punto in bianco. Ma se non è solo Coop e sono tante altre aziende e se queste aziende pungolano le persone da diversi lati, ecco, non dico che il mondo cambia, ma qualcosa inizia a girare.
 Ma perché un’azienda decide di esporsi sul tema? Partiamo da un concetto di base: le aziende sono entità profit che si muovono per perseguire interessi di business. Questo non significa che lo faranno sempre in maniera spregiudicata e senza etica. Non sempre almeno, ed è questo il punto: accettare che si possa posizionare la propria azienda, brand, prodotto o servizio su questi temi per attrarre consumatori, dipendenti, investitori o guadagnarne in termini di buona reputazione e allo stesso tempo farlo in maniera coerente e etica, perseguendo finalità di beneficio comune per la causa.
Ma perché un’azienda decide di esporsi sul tema? Partiamo da un concetto di base: le aziende sono entità profit che si muovono per perseguire interessi di business. Questo non significa che lo faranno sempre in maniera spregiudicata e senza etica. Non sempre almeno, ed è questo il punto: accettare che si possa posizionare la propria azienda, brand, prodotto o servizio su questi temi per attrarre consumatori, dipendenti, investitori o guadagnarne in termini di buona reputazione e allo stesso tempo farlo in maniera coerente e etica, perseguendo finalità di beneficio comune per la causa.
Detto questo, se anni fa potevo essere contento che un’azienda grande ne parlasse e quindi ero anche più tollerante verso attività che erano di rainbowashing, nel 2024 non lo sono più, perché penso che siamo ad una fase di maturità in cui dobbiamo pretendere qualcosa; non basta più solo la visibilità ai nostri temi e alle nostre cause.
Questo perché la diversity e l’inclusion sono due elementi parte dell’ampio mondo ESG – Environmental, Social and Governance, elementi che per le aziende diventano punti strategici per investitori, fondi e banche: ergo è loro interesse dimostrarsi attente e “riconosciute” su questi temi, ergo non dobbiamo “concedere” niente “gratis”. Ora la smetto con le virgolette.
Dunque, dopo questa brevissima parentesi, veniamo a come riconoscere il rainbowashing, in una guida semplice e pratica.
1) Se parliamo di un’azienda grande (ovvero che ha almeno 200 dipendenti), l’iniziativa legata al Pride deve supportare economicamente la comunità LGBTQIA+. La vendita del prodotto/servizio deve portare ad una donazione diretta o continuativa alle associazioni LGBTQIA+. Se un’azienda grande non fa questo, allora sta solo approfittandosi dei nostri diritti e della nostra bandiera.
2) Il luogo di lavoro di quell’azienda deve essere inclusivo e accogliente. Come scoprirlo? Andando sul sito dell’azienda e cercando il Bilancio di Sostenibilità, oppure cercando su Google notizie circa casi di discriminazione o invece di politiche inclusive per la comunità.
3) Una specifica importante: quando un’edizione limitata Pride viene venduta, spesso si dice che verranno devoluti ad associazioni LGBTQIA+ “parte dei ricavati” o “i guadagni” o altre formule simili. Questi termini indicano cose molto diverse e anche un impegno economico diverso. Ad esempio, se un’azienda dona tutto quello che ricava dalla vendita di quel gadget, sta assorbendo anche i costi di produzione e di fatto quell’operazione è un investimento importante. Se devo scegliere, preferisco chi dona in beneficenza tutto il ricavato; a volte leggo di grandi multinazionali che donano il 3% della vendita di un gadget Pride e onestamente un po’ mi viene da storcere il naso (e di questi tempi, direi che siamo tutti più attenti alla cosa).
Questa guida ovviamente non può essere esaustiva e non vuole avere l’arroganza di esserlo. Sono delle indicazioni che io mi son dato, ma che anche io a volte valuto diversamente di caso in caso. Il mio obiettivo però è quello di offrire degli strumenti di base a chi magari non ne ha e soprattutto di spingere alla riflessione su questo tema, che è assolutamente complesso e di certo non risolvibile in quattro parole. In un mondo dove i nostri spazi, i nostri diritti e le nostre cause vengono sempre più ignorati dalla politica, non credo che questo tipo di iniziative “svenda” i nostri diritti, ma credo che possa essere un modo per offrire risorse economiche, visibilità e piattaforme alla nostra comunità che altrimenti ci sarebbero precluse.
[Foto di Kathy Marsh e Alex Jackman]